Categoria: unione civile
Alla Corte Costituzionale l’impossibilità di convertire l’unione civile in matrimonio a seguito della sentenza di rettificazione di sesso di uno dei partner
| 18 febbraio, 2022 | Filled under commenti, identità di genere, italia, OPINIONI, unione civile |
|
di Francesca Barbato*
Pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Lucca del 14 gennaio 2022 con la quale sono state sollevate plurime questioni di legittimità costituzionale con riferimento a disposizioni centrali in ordine all’impossibilità di convertire l’unione civile in matrimonio in conseguenza della rettificazione di sesso di uno dei due componenti della coppia.
Il caso
Nella vicenda in esame XXX , presa piena coscienza della propria disforia di genere di tipo MtF (indicata erroneamente nell’ordinanza FtM) – così come risultante da una relazione psicologica eseguita dal consultorio transgenere di Torre del Lago -, identificandosi irrevocabilmente nel genere femminile, ha adito il Tribunale toscano chiedendo che venisse autorizzato l’intervento chirurgico strumentale alla riassegnazione del sesso da maschile a femminile con conseguente rettificazione dei dati anagrafici riguardanti il sesso, ed ordinato all’ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio con il compagno in luogo dell’unione civile nel registro degli atti di matrimonio. XXX aveva, infatti, contratto un’unione civile nel 2019 con il proprio compagno ed entrambi intendevano conservare il vincolo familiare attraverso l’automatica conversione dell’unione civile in matrimonio a seguito della rettificazione anagrafica.
Nell’esaminare la domanda il Tribunale ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 26, L. 20 maggio 2016, n. 76; 31, commi 3 e 4 bis, D.Lgs. 1°settembre 2011, n. 150 e 70 octies, comma 5 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in relazione agli artt. 2, 3, 117 Cost. e 8 e 14 CEDU quali ai parametri interposti ai sensi dell’art. 117 Cost.
Il giudice di Lucca è partito dalla disamina dell’art. 1, primo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 secondo cui “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” e dell’art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in forza del quale “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Al riguardo il Tribunale ha richiamato gli approdi raggiunti dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale, in virtù dei quali la lettura sinottica delle norme de qua non deve portare a ritenere l’intervento chirurgico pre-condizione necessaria della pronuncia di mutamento di sesso, ma solamente un possibile mezzo strumentale a un pieno benessere psicofisico (Corte cost. n. 221/2015; Cass n. 15138/2015).
Di seguito il giudice ha chiarito come nella fattispecie in esame XXX non ha effettuato un intervento demolitivo-ricostruttivo degli organi sessuali, ma una terapia ormonale, chiedendo la rettifica dell’attribuzione di sesso nei registri di stato civile, dichiarando di aver acquisito l’identità di genere femminile attraverso un percorso psicologico comprovante la definitività e irreversibilità di tale orientamento, prescindendo dalle caratteristiche anatomiche degli organi sessuali. Conseguentemente, in caso di riscontro positivo di quanto allegato nel corso del giudizio, XXX vanterebbe astrattamente l’aspettativa legittima di acquisire una nuova identità di genere anche in assenza di un intervento di adeguamento dei caratteri sessuali.
In siffatte circostanze XXX in una con la suddetta richiesta, deducendo di avere contratto con il proprio partner un’unione civile, ha domandato di ordinare all’ufficiale dello stato civile del Comune di Lucca di iscrivere nel registro degli atti di matrimonio l’unione matrimoniale in luogo di quella civile, in considerazione dell’assenza di un divieto in tal senso da parte dell’ordinamento a svantaggio della coppia in seguito all’acquisto di una nuova identità di genere di uno dei componenti.
Tuttavia il Tribunale ha osservato che “l’interdipendenza tra pronuncia di rettificazione e sorti dell’unione civile in precedenza contratta tra persone dello stesso sesso non forma oggetto di lacuna normativa” (così, p. 4).
Difatti viene ricordato come l’art. 1, comma 26, della L. n. 76 del 2016 preveda (more…)
“Quest’unione civile non s’ha da fare”: il processo a Forza Nuova e l’equiparazione dell’omofobia al razzismo
| 22 gennaio, 2022 | Filled under GenIUS, omo-transfobia, OPINIONI, orientamento sessuale, unione civile, Unioni civili |
|
Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
Il presente elaborato vuole indagare il fenomeno dell’odio razziale in ambito giuridico e non solo, cercando di comprendere se sussistano o meno differenze concrete fra i fenomeni del razzismo e dell’omofobia, i quali traggono origine dal medesimo odio. Si trae spunto da un caso concreto avvenuto nella città di Cesena dove, a pochi mesi dall’approvazione della c.d. legge Cirinnà, mentre le prime due coppie gay si accingevano a celebrare la propria Unione Civile, nella piazza antistante il Municipio alcuni appartenenti a Forza Nuova organizzavano un finto funerale. I partecipanti al corteo funebre saranno tutti rinviati a giudizio per Istigazione all’odio Razziale, avanti al Tribunale di Forlì.>
This paper aims to investigate the phenomenon of racial hatred in the legal field and beyond, trying to understand whether or not there are concrete differences between the phenomena of racism and homophobia, which originate from the same hatred. It is inspired by a concrete case that took place in Cesena where, a few months after the approval of the Cirinnà law, while the first two gay couples were preparing to celebrate their Civil Union, in the square in front of the Town Hall some members of Forza Nuova organized a fake funeral. The participants in the funeral procession will all be sent to trial for Incitement to Racial Hate, before the Court of Forlì.
* Avvocato, Foro di Rimini
(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)
A dieci anni dalla sentenza costituzionale n. 138/2010
| 15 aprile, 2020 | Filled under commenti, discriminazione, genitorialità, italia, matrimonio, OPINIONI, orientamento sessuale, unione civile |
|
di Alexander Schuster
Ero in studio in università il 15 aprile 2010 quando ricevetti la notizia che la Corte costituzionale aveva deciso la questione del matrimonio fra persone dello stesso genere. Nell’estate precedente la Corte di appello di Trento aveva espresso i propri dubbi quanto alla compatibilità con la Costituzione del divieto a contrarre matrimonio. A denunciare la violazione dei loro diritti erano due coppie trentine, l’una composta da due donne, l’altra da due uomini. Non era la prima causa di questo tipo: alcuni mesi prima il Tribunale di Venezia aveva espresso analoghi dubbi. Nemmeno era questione sconosciuta ai giudici italiani in assoluto: il Tribunale di Roma già nel 1980 decise un ricorso proprio contro il rifiuto alle pubblicazioni chieste da una coppia di uomini.
La strategia di affrontare di petto il divieto non scritto di contrarre matrimonio rivolgendo una richiesta all’ufficiale di stato civile e intentando quindi un’azione giudiziaria non era nuova nel panorama mondiale. Il modello fu la cosiddetta “Aktion Standesamt”, ovvero la “Azione stato civile” che nel 1992 in Germania coinvolse ben duecentocinquanta coppie omosessuali. Anche in quel caso si giunse fino alla Corte costituzionale tedesca. Lo stimolo per l’Aktion Standesamt fu l’adozione da parte della Danimarca nel 1989 della prima legge al mondo che consentiva alle coppie di accedere ad una forma di unione registrata.
In Italia dovettero trascorrere molti anni prima di avviare un’iniziativa simile. Elementi scatenanti furono da una parte l’inerzia italiana rispetto agli sviluppi importanti sul fronte del matrimonio di altri Stati occidentali: si pensi alla riforma del matrimonio dei Paesi bassi nel 2001. Dall’altra occorre dare conto delle tanto penose quanto infruttuose discussioni in Parlamento per cercare di abbozzare qualcosa che potesse almeno pavidamente riproporre in salsa italica il PACS francese.
In questo contesto nascono e si alleano sul modello tedesco due associazioni, quella radicale Certi diritti e quella denominata Avvocatura per i diritti LGBT (ora LGBTI). Da lì nacque l’iniziativa di “Affermazione civile”, denominazione coniata dal radicale Sergio Rovasio. Fresco di una tesi di dottorato proprio su questi temi, aderii subito alla proposta di difendere un’idea di giustizia che ancora oggi rimane immutata. Il 23 marzo 2010 si tenne la pubblica udienza in Corte costituzionale. Eravamo presenti anche Francesco Bilotta ed io, quali avvocati delle tre coppie del cui amore e dei cui diritti si dibatteva. A parlare furono opportunamente solo gli avvocati professori universitari che sin da subito sposarono questa battaglia di civiltà: Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D’Amico. Si trattò di un importante lavoro di squadra, forse così unico che non ebbi più modo di riscontrarne di simili negli anni successivi.
Sappiamo che la sentenza n. 138/2010 non garantì il diritto al matrimonio così come chiedevamo. Era un esito atteso, sì che quando mi venne comunicata, l’attenzione si rivolse non all’esito, ma alle motivazioni. La pronuncia non riconosceva la coppia omosessuale come famiglia, ma nemmeno negava che lo fosse. L’impiego di questo termine sarà apparso troppo audace ai quindici giudici di allora. Tuttavia, era significativo che «in relazione ad ipotesi particolari», fosse riconosciuta «la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale». A quest’ultima era così concesso godere, ad esempio, della medesima tutela che era stata accordato alla – questa sì – «famiglia di fatto» eterosessuale. Ciò si evinceva dal richiamo ai precedenti della Corte pronunciati a tutela del convivente (more…)
In dubio, pro matrimonio. A proposito di due decisioni fra matrimonio, unione civile e rettificazione di sesso.
| 8 marzo, 2020 | Filled under commenti, identità di genere, italia, matrimonio, OPINIONI, orientamento sessuale, unione civile |
|
di Denise Amram*
A quasi cinque anni dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l’obbligo di sciogliere il vincolo coniugale in caso di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi (Corte Cost. n. 170/2014, da cui artt. 2 e 4 l. 164/1982)[1], due decisioni di merito, pubblicate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, sollecitano una rinnovata riflessione circa i rapporti intercorrenti tra identità di genere, matrimonio e unione civile.
I casi e le questioni.
Il caso deciso da Tribunale di Brescia, terza sezione civile, decreto del 17 ottobre 2019 n. 11990 concerne un matrimonio tra due persone dello stesso sesso contratto all’estero e trascritto quale unione civile in Italia, cui segue dichiarazione di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due partner e il contestuale sopravvenire del motivo di scioglimento dell’unione ai sensi dell’art. 1, comma 26, l.n. 76/2016[2].
L’ufficiale di stato civile rifiuta la richiesta della coppia che, costretta allo scioglimento del vincolo, chiede la conversione dell’unione civile in matrimonio sulla base del dato letterale dell’art. 70 octies del d.lgs. n. 396/2000 che dispone l’iscrizione nel registro delle unioni civili del vincolo tra persone unite in matrimonio in caso di passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei due coniugi, ma non il viceversa. Il Tribunale di Brescia ordina l’iscrizione del vincolo nel registro del matrimonio sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce del principio di uguaglianza.
Sulla stessa scia, si inserisce la sentenza del Tribunale di Grosseto del 3 ottobre 2019, n. 740 che, nell’ambito di un giudizio volto ad autorizzare con sentenza non definitiva uno dei coniugi a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili, affronta la questione relativa al mantenimento del vincolo matrimoniale laddove entrambi i coniugi, con tempi diversificati, stiano procedendo alla rettificazione anagrafica del sesso. Il Tribunale di Grosseto dispone che, nell’attesa di (more…)
Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212
| 9 maggio, 2019 | Filled under commenti, GenIUS 2019/01, italia, unione civile |
|
Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu
di Giacomo Viggiani*
Il contributo si propone di ricostruire la travagliata vicenda del cognome comune dell’unione civile dall’entrata in vigore della L. 20 maggio 2016, n. 76 fino alla recente sentenza della Corte Costituzionale. In particolare, si offrirà una riflessione sull’ordinanza di rimessione del Tribunale di Ravenna, l’atto di intervento dell’Avvocatura di Stato e, infine, sulla decisione stessa della Corte Costituzionale.
The paper aims at retracing the trouble sequence of events of the common surname of the civil union from the enactment of the law of the 20th May 2016, n. 76 to the recent ruling of the Constitutional Court. In particular, the reflection will focus on the Court of Ravenna’s referral, the act of intervention by the State Attorney and, finally, on the decision itself of the Constitutional Court.
*Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia
Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco




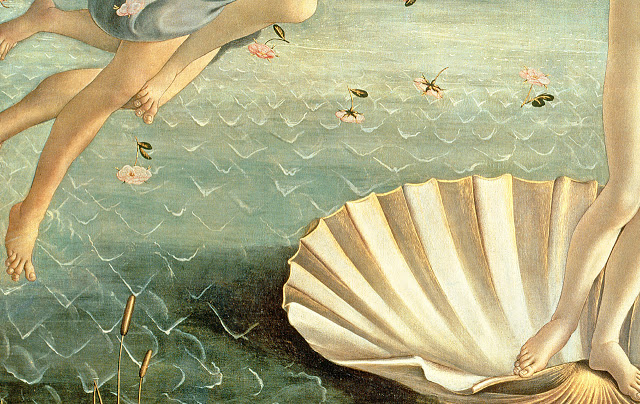
Grande Chambre, Fedotova e altri c. Russia: riaffermato l’obbligo degli stati firmatari della CEDU di riconoscere le coppie dello stesso sesso
di Lorenzo Michelucci
Il 17 gennaio 2023, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha emesso l’attesa sentenza nel caso Fedotova e altri c. Russia (n. 40792/10, 30538/14 e 43439/14), avente come fulcro principale il quesito sul se la Convenzione europea dei diritti dell’uomo comporti un obbligo positivo generale di fornire a coppie dello stesso sesso una forma di riconoscimento legale (che si tratti di matrimonio o – il più possibile – equivalente)
Sebbene il tema della tutela e riconoscimento giuridico delle same-sex couple non sia certo una novità per la Corte, questa è la prima volta in cui la stessa ha riposto direttamente ad un quesito così cruciale nella composizione di Grande Camera, con tutte le conseguenze, ben note, che comporterà in quanto sentenza pilota e massima espressione dell’interpretazione conforme alla Convenzione.
Per inciso, inoltre, questa è stata anche la prima decisione della Corte EDU nei confronti della Stato russo dopo che quest’ultimo ha cessato di essere parte della CEDU (16 settembre 2022) e membro del Consiglio d’Europa (16 marzo 2022).
Ebbene, con quattordici voti contro tre, la Corte ha accertato una violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Federazione Russa in quanto non in grado di giustificare l’assenza di mezzi di riconoscimento giuridico disponibili per le coppie omosessuali a causa di motivi di interesse pubblico. La Russia si era infatti basata su motivi quali: l’importanza della “famiglia tradizionale”, le opinioni negative espresse dalla maggioranza dei russi e la protezione dei minori dalla promozione dell’omosessualità. Tuttavia, la Corte ha escluso di poter accettare tali giustificazioni in quanto rivelatesi nulla più di una generale disapprovazione morale nei confronti delle unioni omosessuali (cfr. par. 217, in cui la Corte ha affermato che non poteva «avallare politiche e decisioni che incarnavano un pregiudizio predisposto da parte di una maggioranza eterosessuale contro una minoranza omosessuale» e che «le tradizioni, gli stereotipi e gli atteggiamenti sociali prevalenti in un determinato paese non possono, da soli, essere considerati una giustificazione sufficiente»).
Inoltre, ad avviso della Grande Camera, la Russia ha mancato pure di identificare un danno oggettivo, individuale o sociale, causato dal riconoscimento delle unioni omosessuali: «Nel caso di specie, non vi è motivo di ritenere che il riconoscimento giuridico e la protezione delle coppie omosessuali in un rapporto stabile e impegnato possano di per sé danneggiare le famiglie costituitesi in modo tradizionale o comprometterne il futuro o l’integrità» (par. 212).
La Corte ha così riconosciuto inequivocabilmente l’esistenza di un obbligo generale positivo, scaturente appunto dalla portata intrinseca dell’art. 8 CEDU, con inevitabili ricadute di portata erga omnes ben oltre il caso in esame. In tal modo, è stato operato un consolidamento della giurisprudenza precedente, frutto anche di una «chiara tendenza in atto» (clear ongoing trend) volta ad un pieno consenso, da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa (30 su 46 membri del CdE), al riconoscimento giuridico delle coppie formate da individui dello stesso sesso. Un punto, questo sul consenso, tra l’altro assente nella decisione adottata precedentemente dalla Terza Sezione della Corte europea.
In merito alla ricostruzione operata dai Giudici di Strasburgo, si legge come l’art. 8 vada ritenuto applicabile non solo nel suo senso tradizionale, ma anche quale diritto di condurre una «vita sociale privata», cioè il diritto di sviluppare la propria identità sociale (par. 143-144). La Corte descrive questo diritto come «la possibilità di avvicinarsi ad altre persone per stabilire e sviluppare relazioni» (ibid.). Se applicato alla situazione delle coppie dello stesso sesso, ciò equivale essenzialmente all’idea che l’orientamento sessuale ha non solo una dimensione privata ma anche pubblica e che le coppie dello stesso sesso dovrebbero essere, in linea di principio, libere e in grado di decidere come presentarsi alla società.
Tornando poi al punto sul consenso della maggioranza degli Stati, è interessante notare come il suo uso sia stato fortemente criticato dal giudice dissenziente Wojtyczek. Secondo il suo parere, la Grande Camera si è basata sul consenso per innescare un «importante cambiamento del paradigma della protezione dei diritti» e «aggiungere nuovi diritti» alla Convenzione, poiché il trattato era originariamente progettato per proteggere esclusivamente le coppie e le famiglie di sesso diverso (par. 3.3). Di conseguenza, a tale opera interpretativa si opporrebbe la necessaria condizione di modifica del Trattato, come ovvio non appannaggio della Corte.
Tuttavia, in Fedotova il consenso non sembra essere utilizzato come un presunto mezzo di modifica del Trattato. Infatti, la Corte ha iniziato la sua analisi esaminando la propria giurisprudenza maggioritaria, stabilendo come l’art. 8 «è già stato interpretato come obbligo per uno Stato contraente di garantire il riconoscimento e la protezione giuridica per le coppie dello stesso sesso, mettendo in atto un “quadro giuridico specifico”» (par. 164). Solo successivamente, la Corte si è concentrata sul consenso nazionale e internazionale per consolidare questi risultati. Pertanto, il consenso non è mai stata l’unica base, né la giustificazione principale per sancire il suddetto obbligo positivo.
Proprio al fine di evitare fraintendimenti, la Corte è stata casomai attenta ad evidenziare, nei paragrafi 179-180, che «questa interpretazione dell’articolo 8 è guidata dalla preoccupazione di garantire una protezione efficace della vita privata e familiare delle persone omosessuali» e dai «valori della società democratica come “pluralismo, tolleranza e apertura mentale”», e inoltre in linea con «lo spirito generale della Convenzione».
Dall’altra parte, in linea con la sentenza della Camera, la Grande Camera (more…)