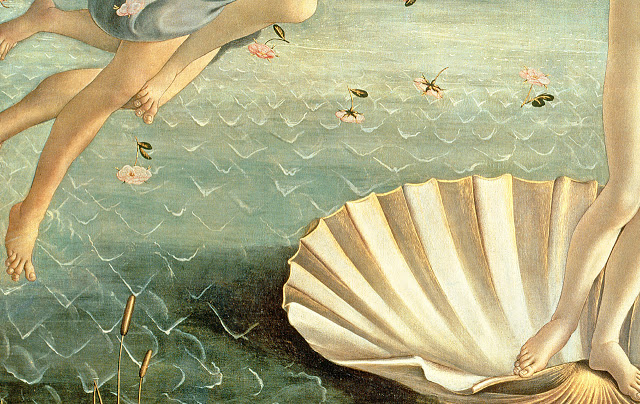Corte d’Appello di Milano, sezione lavoro, sentenza 29 marzo – 31 agosto 2012, n. 7176
Fatto e diritto
Con ricorso al Tribunale di Milano C.M. conveniva in giudizio la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo per sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere l’iscrizione del proprio compagno convivente sig. E.G. alla Cassa convenuta, ordinare alla stessa la predetta iscrizione, dietro versamento dell’importo dovuto, nonché condannare la Cassa al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo rifiuto di iscrizione, nella misura da accertarsi in causa e/o ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Premesso che era stato assunto dalla Banca di Credito Cooperativo nel 1999 e che il contratto di assunzione prevedeva che il dipendente fruisse, a fronte di un contributo da trattenersi in busta paga, dell’assistenza per esigenze sanitarie previste dalla Cassa Mutua Nazionale per il personale della Banche di Credito Cooperativo; che l’articolo 4 statuto della Cassa prevede che hanno diritto alle prestazioni i “destinatari, i loro familiari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato familiare fiscalmente a carico”; che le Istruzioni operative dell’anno 2007, all’articolo 6, pagina 14 disciplinano le modalità di iscrizione prevedendo, tra l’altro, che “il neoassunto può richiedere l’iscrizione del coniuge non fiscalmente a carico e di altri familiari entro il primo grado, purché conviventi non fiscalmente a carico e del convivente more uxorio solo con reddito lordo…”,; esponeva che egli, richiesta l’iscrizione, quale beneficiario delle prestazioni della Cassa, del proprio convivente signor E.G., provvedendo ad effettuare il relativo bonifico di euro 215,00, si era visto respingere la domanda con la motivazione che il mancato accoglimento era da ricondurre “sia ad aspetti prettamente giuridici sia ad aspetti interpretativi”; in particolare il Comitato Amministratore aveva ritenuto che la norma facesse riferimento esclusivo ad un istituto (il matrimonio) attualmente non ammesso dalla legislazione statale per le coppie dello stesso sesso, per quanto attiene all’interpretazione della norma statutaria, aveva ribadito che l’intenzione non era quella di comprendere nella casistica anche coppie omosessuali.
Deduceva che la norma richiamata dalla Cassa non faceva esplicito riferimento al matrimonio, differenziando, anzi, esplicitamente le figure del coniuge da quella del convivente more uxorio e l’intenzione dei redattori della norma non poteva valere come valido ed unico criterio interpretativo. Evidenziando che esso ricorrente ed il Sig. E.G. conducevano da quattro anni vita in comune, sia sotto l’aspetto dell’affectio coniugalis, sia sotto il profilo economico dell’animus donandi; che risultavano altresì come famiglia anagrafica da certificato di stato di famiglia rilasciato dall’ufficio anagrafe del Comune di Milano; che le spese di casa, mutuo, riparazioni, venivano sopportati da entrambi, sostenendosi economicamente e moralmente per ogni necessità, deduceva l’illegittimità del rifiuto di iscrizione del proprio convivente alla Cassa; sosteneva in ogni caso che la norma, nel senso propugnato dalla Cassa, costituiva un’evidente caso di discriminazione diretta, in violazione dell’articolo 2 del D. Lgs 216/2003, sottolineando che nel caso di specie non veniva affatto in rilievo la questione del riconoscimento delle coppie di fatto a livello nazionale e di diritto di famiglia, chiedendosi semplicemente una prestazione previdenziale incidente in un ambito strettamente privatistico ed un beneficio concernente unicamente in diritto del lavoro. La Cassa convenuta resisteva alle domande di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza n. 5267/09 il Giudice adito accoglieva la domanda relativa all’iscrizione alla cassa del convivente del ricorrente richiamando, quale criterio ermeneutico, l’art. 1369 c.c., e rilevando che il riferimento al “matrimonio”, come concepito dalla legislazione nazionale, fosse solo uno dei possibili significati dell’espressione “more uxorio” in contestazione tra le parti, con la conseguenza che doveva privilegiarsi una interpretazione atta a garantire il raggiungimento dello scopo della previsione statutaria (ossia l’assistenza sanitaria dei destinatari e dei loro familiari aventi diritto, ad integrazione o sostituzione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale) e ad evitare una discriminazione per motivi di orientamento sessuale. Rigettava invece la domanda d risarcimento danni. Avverso la predetta decisione ha proposto appello la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo lamentando che l’interpretazione fornita dal primo giudice si porrebbe in contrasto la volontà delle parti contraenti.
Secondo l’appellante la previsione dell’art. 4 dello Statuto nella parte in cui individua come destinatari del beneficio dell’assistenza sanitaria anche il “convivente more uxorio” dovrebbe intendersi limitata all’estensione dei benefici alle sole coppie composte da un uomo e una donna che, pur non essendo sposati, convivono: l’espressione usata nello Statuto sarebbe quindi riferibile esclusivamente all’unione di due persone di sesso diverso, dovendosi escludere l’estensione dei benefici alle coppie omosessuali. Secondo la prospettazione dell’appellante questa sarebbe, non solo l’unica interpretazione conforme alla volontà delle parti, ma altresì l’unica coerente con il significato generalmente attribuito all’espressione “more uxorio”, secondo le definizioni rinvenibili nei numerosi dizionari della lingua italiana allegati per estratto agli atti di causa. Sostiene che, così come previsto dal brocardo latino “in claris non fit interpretatio” ove il senso letterale delle parole sia chiaro, l’interprete non potrebbe sovrapporvi una comune interpretazione da esso divergente. Oltretutto, ai sensi dell’articolo 1362 c.c., dovendo farsi riferimento alla “comune volontà delle parti”, ciò che rileva sarebbe la comune volontà manifestata il 16 marzo 1994, data in cui è stato approvato lo Statuto della Federcasse e dalle OO.SS le quali, nel redigere l’art. 4, hanno appositamente menzionato la convivenza more uxorio riferendosi consapevolmente ed esclusivamente alla convivenza tra uomo e donna. Ha poi evidenziato che in Italia non era, e non è, ad oggi, riconosciuta la convivenza omosessuale, per cui non è riconducibile alla comune intenzione delle parti la possibilità di comprendere tra i beneficiari delle prestazioni sanitarie le coppie omosessuali, anche a prescindere dal fatto che risultino conviventi dallo stato di famiglia. Nessuna discriminazione sarebbe d’altro canto ravvisabile, poiché allo stesso modo potrebbe sostenersi la violazione della parità di trattamento da parte di tutti i parenti non rientranti nel primo grado, esclusi dal benefici in discorso a mente dell’art. 4 comma 12 dello Statuto.
L’appellato ha resistito, rinunciando espressamente alla domanda di risarcimento danni proposta in prime cure e chiedendo la conferma della gravata sentenza.
Dopo la discussione all’udienza del 29 marzo 2012 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. L’oggetto di giudizio attiene esclusivamente all’individuazione dell’esatta portata della previsione di cui all’art. 4, co. 1, dello Statuto della Cassa nella parte in cui estende il diritto alle prestazioni della Cassa ai familiari a carico del beneficiario e al convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia. La stabile convivenza tra C.M. ed E.G., l’unicità della famiglia anagrafica così come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Milano, la comunione di vita degli stessi (tanto sotto il profilo affettivo, quanto sotto profilo economico) sono tutte circostanze pacifiche in giudizio in quanto non contestate. Il merito, pertanto, risulta circoscritto a una questione di natura esclusivamente interpretativa in particolare dell’art. 4 dello Statuto, rubricato “beneficiari delle prestazioni”. La Corte anzitutto non condivide dell’affermazione dell’appellante secondo la quale occorrerebbe fare riferimento in via prioritaria al criterio di interpretazione letterale.
Come noto in materia di ermeneutica contrattuale, cui la Cassa ha fatto correttamente riferimento, nel valutare l’aspetto letterale (che nella interpretazione della legge presenta un peso maggiore che nella interpretazione del contratto, diretta, quest’ultima alla ricostruzione della “comune intenzione delle parti”), le parti possono adottare linguaggi convenzionali, a volte diversi da quello comune, sì che il brocardo “in claris non fit interpretatio” non è neppure completamente pertinente in relazione all’interpretazione del contratto, se non nel senso che occorre stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto o se occorra accertarla mediante un’ulteriore indagine secondo le regole stabilite dal codice. La norma di cui all’art. 1362 c.c., che svolge un ruolo preminente nel contesto delle disposizioni sull’interpretazione del contratto, individua infatti quale oggetto di indagine la “comune intenzione” delle parti e, quali strumenti di ermeneutica, non solo la lettera del testo contrattuale, ma l’intero comportamento delle parti, “anche” posteriore alla conclusione del contratto. Al medesimo scopo contribuiscono poi le successive norme, di c.d. interpretazione soggettiva, di cui agli artt. 1363, 1364 e 1365 c.c., mentre i criteri di c.d. interpretazione oggettiva, che poggiano su altri elementi non riconducibili all’intenzione delle parti, sono contemplati dagli articoli successivi 1366-1370 c.c.; la prima di dette norme (art. 1366 c.c.), relativa alla buona fede, è stata pervero tradizionalmente ritenuta (in base alla relazione al codice) una norma di “cerniera” o di collegamento tra quelle di interpretazione soggettiva e quelle di interpretazione oggettiva. Anche secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali si deve ritenere che il canone della buona fede rappresenti l’anello di congiunzione tra la ricerca della reale volontà delle parti (che costituisce di norma il passaggio primo del processo ermeneutico) e il persistere di un dubbio sul contenuto della volontà contrattuale, ovvero l’esigenza di tutelare l’affidamento che un terzo abbia maturato il significato obiettivo della dichiarazione frutto della volontà dei contraenti originari. In particolare la Suprema Corte ha affermato che “il criterio della buonafede nella interpretazione dei contratti, deve ritenersi funzionale ad escludere il ricorso a significati unilaterali o contrastanti con un criterio di affidamento dell’uomo medio, ma non consente di assegnare all’atto una portata diversa da quella che emerge dal suo contenuto obiettivo, corrispondente alla convinzione soggettiva di una singola persona. Esso rappresenta, difatti, il punto di sutura tra la ricerca della reale volontà delle parti (costituente il primo momento del processo interpretativo, in base alla comune intenzione ed al senso letterale delle parole) ed il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della volontà contrattuale (in base ad un criterio obbiettivo, fondato su di un canone di reciproca lealtà nella condotta tra le parti, ed inteso alla tutela dell’affidamento che ciascuna parte deve porre nel significato della dichiarazione dell’altra), e rappresenta, pertanto, un mezzo, alfine, soltanto sussidiario dell’interpretazione, non invocabile quando il giudice di merito abbia, attraverso l’esame degli elementi di prova raccolti, già “aliunde” accertato l’effettiva volontà delle parti (Cass. 18.5.2001, n. 6819)” (Cass. Civ., Sez. III, 15 marzo 2005, n. 5239, parte motiva).
Ciò evidenziato dal punto di vista generale su criteri di ermeneutica contrattuale, non può condividersi il motivo d’appello secondo il quale il primo giudice avrebbe errato nel fare riferimento all’art. 1369 c.c., non ravvisandosi alcun dubbio sulla reale volontà delle parti poiché le espressioni contenute nell’art. 4 dello Statuto sarebbero del tutto univoche secondo il significato attribuibile alla locuzione “more uxorio” rinvenibile nei Dizionari della lingua Italiana tenuto presente dalle parti contraenti. La Corte ritiene non pertinente il richiamo ai criteri di interpretazione soggettiva ed in particolare a quello preminente costituito dalla individuazione della “comune intenzione delle parti” valorizzato dall’appellante. A tali criteri non può farsi riferimento nelle ipotesi in cui debba procedersi all’interpretazione di quei contratti dai quali sorgono nuove entità giuridicamente rilevanti destinate a suscitare l’affidamento dei terzi sulle regole pattizie che ne regolamentano il funzionamento (si pensi, ad esempio, ai contratti associativi). In contratti di tal natura, infatti, l’esigenza di indagare la comune intenzione dei contraenti non può prevalere sulla contrapposta esigenza di tutelare l’affidamento che i terzi, che si rapportano con il soggetto di diritto sorto da quel contratto, abbiano riposto sul significato oggettivo dell’accordo. Ogniqualvolta il conflitto circa il significato di una determinata pattuizione coinvolge parti contraenti e soggetti terzi, estranei alla formazione del regolamento contrattuale, l’interpretazione non può assumere una prospettiva soggettiva atta a ledere l’affidamento che questi ultimi abbiano riposto nella stabilità oggettiva dell’espressione richiamata.
In sostanza, nei casi in esame, nell’astratta contrapposizione tra effettiva comune intenzione dei contraenti e oggettiva rilevanza della previsione secondo lo schema sociale e linguistico di riferimento, non può che prevalere la seconda, dovendosi attribuire preminente rilevanza alla realtà economico-sociale in cui il contratto è destinato a inserirsi. Si osserva che la Suprema Corte (v. sent. 10970/1996), in una fattispecie relativa alla interpretazione dell’atto costitutivo di una società per azioni omologata ed iscritta come tale nel registro delle imprese, ma della quale si pretendeva di dimostrare la natura effettiva di società a responsabilità limitata, ha affermato come “più consono… il ricorso a criteri di interpretazione obbiettivi, piuttosto che a quelli fondati sulla comune intenzione dei contraenti (artt. 1362 c.c.)”.
Con la pronuncia n. 11756 del 19/05/2006 (emessa in fattispecie relativa alla Cassa sovvenzioni per il personale dell’amministrazione finanziaria e alla natura ordinatoria del termine stabilito dall’art. 17 dello statuto) la stessa S.C. ha affermato che “le disposizioni dello statuto di un’associazione, come, del resto, quelle dell’atto costitutivo, hanno natura negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Nell’interpretazione di tali disposizioni deve farsi applicazione delle regole stabilite dall’art. 1362 c.c. ss., prescindendo dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori ed utilizzando le sole regole dell’interpretazione oggettiva”
Occorre dunque far riferimento ai criteri di interpretazione oggettiva che muovono dall’art. 1366 c.c., ossia dall’esigenza di interpretare il contratto sempre “secondo buona fede” che, come si è già osservato, rappresenta una sorta di anello di congiunzione tra la ricerca della reale volontà delle parti e il persistere di un dubbio sul contenuto della volontà contrattuale.
Poggiando sul principio fondamentale della buona fede, il procedimento di interpretazione oggettiva esige poi di tener conto degli ulteriori canoni delineati dall’ordinamento civilistico e, quindi, dell’esigenza di dare alle clausole un senso utile alla produzione di effetti (art. 1367 c.c.), un significato conforme a ciò che generalmente si pratica nel luogo in cui il contratto è stato concluso (art. 1368 c.c.), il contenuto più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto (art. 1369 c.c.) e, infine, il significato favorevole alla parte che non ha partecipato alla formazione della clausola (art. 1370 c.c.). Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che C.M., quale beneficiario della CASSA MUTUA NAZIONALE, sia soggetto terzo titolare di uno specifico affidamento circa il significato oggettivo delle previsioni dello Statuto e istruzioni operative della Cassa.
Osserva allora la Corte che l’art. 4 dello Statuto stabilisce espressamente che “hanno diritto alle prestazioni della Cassa di Destinatari, i loro famigliari fisicamente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico…”. L’art. 6 delle Istruzioni operative prevede poi che “il neo assunto può chiedere l’iscrizione del coniuge non fiscalmente a carico e di altri famigliari entro il primo grado, purché conviventi non fiscalmente ad carico e del convivente more uxorio con reddito lordo superiore a euro 2.840,51, nei termini previsti dallo Statuto…”.
Sotto un profilo prettamente oggettivo, deve osservarsi come le previsioni appena richiamate non contengano indicazione o distinzione alcuna in ordine al sesso dei beneficiari aggiuntivi e, conseguentemente, in ordine all’esigenza che il convivente more uxorio debba essere riferito a un soggetto di sesso diverso rispetto al beneficiario principale.
Come correttamente evidenziato dall’appellante nel proprio atto difensivo, la CASSA MUTUA NAZIONALE è stata istituita “quale specifico strumento per garantire l’assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane…” (pagg. 3-4, il ricorso in appello). Per espressa previsione dello Statuto, tale beneficio viene esteso a determinate categorie di soggetti e, più nello specifico, ai familiari fiscalmente a carico, al convivente more uxorio equiparabile al familiare fiscalmente a carico, e – seppur previa autorizzazione del Comitato Amministratore – al coniuge anche se non convivente e agli altri familiari conviventi con il destinatario. Previa richiesta scritta, peraltro, è altresì ammesso il convivente more uxorio con reddito superiore a quello previsto per essere considerato familiare a carico.
L’art. 4 stabilisce poi che “l’ammissione ai benefici per altri famigliari conviventi e per gli altri soggetti di cui ai commi precedenti deve comprendere obbligatoriamente l’estensione a tutti i famigliari non fiscalmente a carico, come definiti nel presente Statuto, tranne che per coloro che già beneficino di altre coperture assistenziali, assicurative e/o mutualistiche”, e che “il neo assunto, per i famigliari conviventi non fiscalmente a carico e per gli altri soggetti di cui ai commi precedenti, deve richiedere l’ammissione ai benefici, pena la decadenza dal diritto per l’anno in corso, entro 60 giorni dalla data di assunzione… Con il termine “Famigliari”, ai fini statutari, si intendono il coniuge ed i parenti di 1° grado del Destinatario”. Da quanto sin qui richiamato emerge che, fatta salva l’eccezione espressamente prevista per il coniuge, la condizione essenziale per l’estensione dei benefici delle prestazioni in parola, tanto con riferimento ai familiari di primo grado, quanto con riferimento al soggetto terzo con il quale vi sia comunione di vita, è data dalla convivenza con il destinatario primo delle prestazioni della Cassa. È, questa, una considerazione che trova conferma nel già citato art. 6 delle Istruzioni operative che, all’ottavo comma, espressamente stabilisce che “non è previsto dallo Statuto, per il solo coniuge non fiscalmente a carico, l’obbligo della convivenza”. Sotto un profilo sempre oggettivo, quindi, il requisito della convivenza assurge a primo presupposto per il riconoscimento dei diritti ivi rivendicati. Tale rilievo porta a ritenere che la funzione delle previsioni in commento, tenuto conto della natura e dell’oggetto delle prestazioni di cui si discute, sia quello di estendere i benefici in parola dall’ambito tipicamente matrimoniale al più ampio ambito di convivenza familiare latamente intesa. Ciò posto, l’odierna appellante afferma che il riferimento alla convivenza more uxorio non potrebbe che essere inteso quale richiamo alla sola unione di due persone di sesso diverso, e fonda tale assunto sulle definizioni alla stessa date tra il 1971 e il 1997 (v. fotocopie dei dizionari prodotte). Al riguardo, non potendosi riconoscere all’espressione in esame un senso univoco (risultando il significato propriamente letterale difforme dal senso socialmente attribuitole nell’epoca contemporanea), e dovendosi far riferimento per le ragioni già sopra evidenziate ai canoni di interpretazione oggettiva, deve osservarsi quanto segue.
L’applicazione del principio di buona fede porta a escludere che all’espressione “convivenza more uxorio” possa essere riconosciuto il significato attribuitole in un’epoca ormai risalente, dovendo la stessa essere interpretata in considerazione dell’attuale realtà economico-sociale, degli schemi oggi socialmente riconosciuti.
Al riguardo, giova rammentare come la Corte Costituzionale, con sentenza del 23 marzo 2010, n. 138, abbia affermato che “l’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri” (parte motiva).
Con la citata pronuncia, la Consulta ha in sostanza affermato che anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, costituisce una formazione sociale ex art. 2 Costituzione e che, in quanto tale, le persone che la compongono sono titolari del diritto fondamentale di vivere liberamente la condizione coppia.
La pronuncia in commento segue quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella quale si è affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali impone la qualifica di famiglia anche alle unioni formate da persone dello stesso sesso (cfr. Prima Sezione, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria).
Recentissimamente, infine, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4184 del 15 marzo scorso, ha osservato che “già da tempo ed attualmente, la realtà sociale e giuridica Europea ed extraeuropea mostra, sul piano sociale, il diffuso fenomeno di persone dello stesso sesso stabilmente conviventi e, sul piano giuridico, sia il riconoscimento a tali persone, da parte di alcuni Paesi Europei (anche membri dell’Unione Europea, come nella specie) ed extraeuropei, del diritto al matrimonio, ovvero del più limitato diritto alla formalizzazione giuridica di tali stabili convivenze e di alcuni diritti a queste connessi, sia – come si vedrà più oltre in dettaglio (cfr., infra, nn. 3.3.1. e seguenti) – un’interpretazione profondamente “evolutiva” dell’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.
Ha infine affermato che “componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia – quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”
Le pronunce sin qui richiamate consentono, quindi, di affermare che nell’attuale realtà politico-sociale la convivenza more uxorio, intesa quale comunione di vita caratterizzata da stabilità e dall’assenza del vincolo del matrimonio, nucleo familiare portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, non è soltanto quella caratterizzata dall’unione di persone di sesso diverso, ma è altresì quella propria delle unioni omosessuali alle quali il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa.
Le previsioni dello Statuto già sopra richiamate depongono a favore di un’interpretazione utile a garantire l’estensione dei benefici ivi previsti alle unioni di fatto equiparabili a quelle scaturenti dal matrimonio in quanto rientranti nella nozione comune di convivenza more uxorio.
È questa è una condizione che deve essere riconosciuta, nella società attuale, anche alle convivenze omosessuali. Quella appena delineata è, peraltro, l’interpretazione più coerente con la natura e con l’oggetto del contratto che ha, con tutta evidenza, una funzione di solidarietà e assistenza. Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, infatti, lo scopo della Cassa è di “fornire, con esclusione di ogni finalità di lucro, assistenza per esigenze sanitarie dei Destinatari di cui all’art. 3 e loro famigliari aventi diritto, ad integrazione e/o sostituzione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale”.
Tale funzione verrebbe frustrata ove si aderisse alla tesi dell’odierno appellante.
Alla luce di quanto sin qui considerato, non può che concludersi per la correttezza della decisione del Giudice di prime cure che ha ritenuto che sarebbe del tutto arbitrario (oltreché discriminatorio] escludere un convivente risultante dallo stato di famiglia solo per una questione di uguaglianza sessuale rispetto al richiedente. L’appello va in definitiva respinto e tuttavia la natura interpretativa della decisione, la complessità e delicatezza della materia giustificano la compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l’appello avverso la sentenza n. 5267/09 del Tribunale di Milano; compensa le spese del grado.