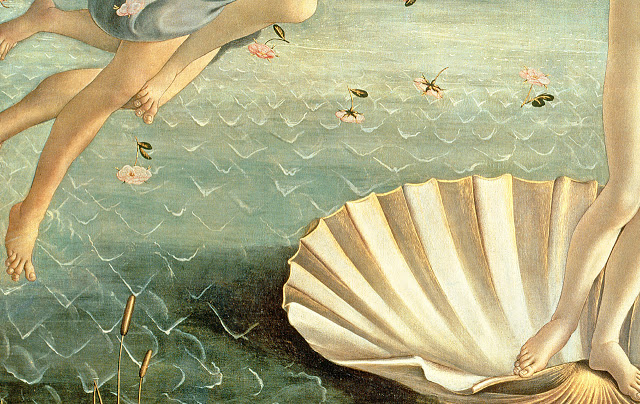Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”
| 26 giugno, 2014 | Filled under identità di genere, italia, matrimonio, OPINIONI |
|
di Giuditta Brunelli *
1. Una pronuncia contraddittoria – 2. Come tutelare effettivamente i diritti costituzionali dei soggetti coinvolti – 3. Una motivazione deludente – 4. Contro la frammentazione delle tipologie familiari
1. Ciò che colpisce nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014, sul c.d. “divorzio imposto”, è il contrasto tra il dispositivo di accoglimento (sia pur additivo di principio) e una motivazione che nulla innova rispetto alle ambiguità della precedente pronuncia n. 138 del 2010, confermandone i principali passaggi argomentativi, peraltro riproposti con tono più sbrigativo, meno approfondito e decisamente conservatore. Su questi aspetti tornerò tra breve. Ma il primo punto su cui vorrei soffermarmi è proprio quello della necessità di risolvere questa contraddizione tra parte motiva e parte decisoria della sentenza, dalla quale potrebbe derivare una situazione di pericolosa indeterminatezza per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.
2. Siamo di fronte, come dicevo, ad un dispositivo di accoglimento, che non può non determinare una modificazione dell’ordinamento. Certo, si tratta di un’additiva di principio, che – in quanto tale – non formula una regola immediatamente applicabile (plurime essendo le soluzioni normative ipotizzabili, e dunque affidate alla discrezionalità del legislatore), ma, appunto, un principio, che vincola il legislatore nel compito di dettare la disciplina necessaria e affida «ai giudici comuni, caso per caso, quando è possibile, quello di reperire nell’ordinamento la regola del caso concreto, in attesa di un intervento legislativo puntuale» [G.Zagrebelsky-V.Marceno’, Giustizia costituzionale, Bologna, il Mulino, 2012, 403]. Si tratta, com’è noto, di uno strumento decisorio elaborato dal giudice delle leggi per evitare vuoti di tutela nell’ambito dei diritti fondamentali (soprattutto dei diritti sociali), e che la Corte utilizza proprio quando intende incidere sul sistema normativo; se così non fosse, si limiterebbe (come avrebbe potuto fare in questo caso) a pronunciare una inammissibilità con monito al legislatore, che, com’è noto, si muove invece sul piano della semplice persuasività. E’ pertanto necessario individuare una soluzione transitoria che riconosca la forza giuridica intrinsecamente connessa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale: e, in questo senso, la soluzione qui proposta da Barbara Pezzini, secondo cui gli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 potranno produrre gli effetti propri dello scioglimento soltanto quando entrerà in vigore una disciplina legislativa che consenta la conversione del matrimonio in una convivenza registrata, mi sembra ragionevole, rispettosa delle diverse competenze costituzionali (Corte, legislatore, giudici comuni) e, soprattutto, idonea a tutelare le posizioni soggettive dei coniugi (le quali, come nota giustamente Pezzini, subiscono comunque un deterioramento, derivante dalla dimensione di precarietà giuridica in cui vengono a trovarsi).
Solo in questo modo diventa possibile dare un significato ad una sentenza che apparirebbe altrimenti di difficile interpretazione, ed è necessario farlo anche al di là delle stesse parole della Corte, che, nell’invitare il legislatore ad intervenire con la massima sollecitudine per porre rimedio all’ “attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti (…) coinvolti”, appare altrimenti orientata. Quel che conta, infatti, è la natura del dispositivo, insieme al principio, ribadito con nettezza dallo stesso giudice costituzionale nella pronuncia, anch’essa recentissima, sulla fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), secondo cui la violazione di una libertà fondamentale «non può mai essere giustificata con l’eventuale inerzia del legislatore ordinario. Una volta accertato che una norma primaria si pone in contrasto con parametri costituzionali, questa Corte non può (…) sottrarsi al proprio potere-dovere di porvi rimedio e deve dichiarare l’illegittimità, essendo poi “compito del legislatore introdurre apposite disposizioni” (sentenza n. 278 del 2013), allo scopo di eliminare le eventuali lacune che non possano essere colmate mediante gli ordinari strumenti interpretativi dai giudici ed anche dalla pubblica amministrazione, qualora ciò sia ammissibile». Parole inequivocabili.
3. Detto questo, non vi è dubbio che si tratti di una sentenza assai deludente, per una serie di motivi. In primo luogo, per l’insistenza sul modello eterosessuale di matrimonio accolto dal nostro ordinamento, anzi sul carattere essenziale dell’eterosessualità presupposto dall’art. 29 Cost. nel rinviare implicitamente alla definizione dell’istituto contenuta nel codice civile del 1942. Intendiamoci: nulla di nuovo, nella sostanza, rispetto alla pronuncia n. 138 del 2010. Vi è semplicemente la riproposizione dell’interpretazione originalista e tradizionalista della disposizione costituzionale, che tuttavia non postula affatto la necessità di una sua revisione per introdurre il matrimonio same-sex [come ho cercato di argomentare altrove: G. Brunelli, Le unioni omosessuali nella sentenza n. 138/2010: un riconoscimento senza garanzia?, in Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza n. 138 del 2010: quali prospettive?, a cura di B. Pezzini e A.Lorenzetti, Napoli, Jovene, 2011, 144 ss. e 152 ss.]. Del resto, la stessa decisione del 2010 ha precisato che la Costituzione non ha inteso in alcun modo «cristallizzare» una nozione immutabile di matrimonio (basti pensare al carattere dell’indissolubilità, eliminato con la legge n. 898 del 1970). A ragionare diversamente, si commetterebbe un grave errore giuridico, dal momento che «in tutte le sedi giurisdizionali (e quindi non solo in quella costituzionale) occorre interpretare le leggi ordinarie alla luce della Costituzione, e non viceversa» (sentenza n. 1 del 2013).
E, tuttavia, la perseveranza nel ribadire una siffatta lettura dell’art. 29 Cost., che addirittura lo esclude dai parametri costituzionali di riferimento per la valutazione della fattispecie all’attenzione della Corte, rischia di consolidare le correnti più conservatrici della cultura giuridica e – soprattutto – di rafforzare gli orientamenti politici più ostili al cambiamento.
Ma molti altri sono gli aspetti insoddisfacenti della motivazione, che mi limito ad indicare in modo sintetico.
a) L’irrilevanza in cui è confinato l’art. 3, comma 1, Cost., che corrisponde all’esclusione del profilo discriminatorio della normativa impugnata, valutata infatti soltanto attraverso il criterio, indubbiamente più blando, della ragionevolezza, intesa come coerenza dell’ordinamento nel disciplinare fattispecie tra loro non assimilabili. Esattamente come accaduto nella decisione n. 138, anche in questo caso la Corte non utilizza il canone dell’eguaglianza nel senso forte di divieto di discriminazione, come vero e proprio “diritto all’eguaglianza soggettiva”, che si manifesta nella giurisprudenza costituzionale ove entri in gioco il nucleo qualificante del principio, cioè quei profili che hanno a che fare con la libertà e la dignità della persona. Qui, al contrario, ci si ferma alla ragionevolezza, limitandosi ad osservare (senza adeguato approfondimento) che “la diversità della peculiare fattispecie di scioglimento a causa di mutamento del sesso di uno dei due coniugi rispetto alle altre cause di scioglimento del matrimonio ne giustifica la differente disciplina”.
b) Anche oggi, come nel 2010, la Corte non parte dalla considerazione della realtà sociale e dalla domanda di riconoscimento (rectius: di estensione) di un diritto che da essa proviene, ma dalla definizione di un istituto giuridico (il matrimonio come delineato nel codice civile) che non sarebbe possibile “snaturare” nei suoi caratteri costitutivi essenziali, tra i quali rientra l’eterosessualità. In questo senso va inteso il riferimento all’ interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio, che andrebbe bilanciato con «l’interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso dell’altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del precedente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in vita (…)». La normativa impugnata presenta profili di incostituzionalità proprio in quanto risolve un tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell’istituto del matrimonio, senza bilanciarlo adeguatamente con gli interessi della coppia «non più eterosessuale». Ora, è vero che anche nella giurisprudenza di Strasburgo si parla di «State’s interest to maintain the traditional institution of marriage intact» (Corte Edu, quarta sezione, H. c. Finlandia, 13 novembre 2012), ma non sembra che le due nozioni possano essere meccanicamente sovrapponibili. Un conto, infatti, è il giudizio affidato ad una Corte sovranazionale, che deve per sua stessa natura mantenere uno sguardo “esterno” sugli ordinamenti degli Stati membri, come dimostra la stessa dottrina (pur non priva di ambiguità) del “margine di apprezzamento”; altra cosa è il controllo di costituzionalità della legge, nel cui ambito, laddove opera per bilanciamenti, la Corte costituzionale non può esimersi da una precisa e appropriata definizione degli interessi in gioco. L’apodittico riferimento ad un interesse dello Stato a conservare inalterati i caratteri tradizionali di un istituto giuridico di tale rilievo sembra in questo caso evocare una sorta di etica di Stato, impermeabile alle inevitabili evoluzioni di una società pluralista. La domanda a cui sarebbe invece necessario rispondere (e alla quale la Corte, ancora una volta, non risponde), riguarda l’esistenza e la conseguente definizione di un interesse costituzionale concorrente che giustifichi il persistente divieto di matrimoni same-sex. Interesse che dovrebbe radicarsi in altre posizioni soggettive costituzionali a rischio di compromissione (ma quali?), e non certo in una pretesa di conservazione dello Stato.
c) Impressiona, infine, la sottovalutazione della giurisprudenza della Corte Edu, richiamata soltanto per l’affermazione secondo cui, in assenza di un consenso tra i vari Stati nazionali sul tema delle unioni omosessuali, si riconosce agli Stati medesimi un margine di apprezzamento in materia, restando affidate alla discrezionalità del legislatore nazionale le eventuali forme di tutela giuridica per le coppie di soggetti appartenenti al medesimo sesso – circostanza che rende non pertinente il riferimento agli artt. 8 (sul rispetto della vita familiare) e 12 (sul diritto di sposarsi e di formare una famiglia) della Cedu, invocati come norme interposte ai sensi della violazione degli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost. Qui davvero la Corte costituzionale decide di ignorare che il paradigma eterosessuale del matrimonio ha cominciato a sgretolarsi nel sistema Cedu, al quale anche l’Italia appartiene, a partire dalla sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, secondo la quale l’art. 12 Cedu, reinterpretato alla luce dell’art. 9 della Carta di Nizza-Strasburgo, si riferisce anche al matrimonio omosessuale. Oggi, dunque, la nozione di matrimonio accolta nel sistema della Convenzione europea contiene in sé il same-sex marriage, riconosciuto in numerosi Stati membri del Consiglio d’Europa. E, com’è noto, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, le norme della Cedu, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, integrano, come norme interposte, il parametro espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., entrando così a far parte del materiale normativo cui deve conformarsi la legislazione ordinaria, in base al principio secondo cui «la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (Corte cost., sentenze n. 264 del 2012 e n. 170 del 2013). Date queste premesse, quando la stessa Corte costituzionale, in alcune pronunce, enuncia il diritto fondamentale al matrimonio, fondandolo – oltre che sugli artt. 2 e 29 Cost. e sull’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 – sull’art. 12 della Cedu (da ultimo, sentenza n. 245 del 2011), non può ignorare l’attuale interpretazione di tale disposizione nella giurisprudenza di Strasburgo. E, dunque, l’ingresso nel nostro ordinamento di una nozione di matrimonio che non esclude dal suo orizzonte la dimensione omosessuale (significativa, sotto questo aspetto, la sentenza n. 4184 della Corte di cassazione, sez. I civile, del 15 marzo 2012). Ma nulla di tutto questo sembra rilevare nella decisione n. 170 del 2014.
4. Una decisione che, peraltro, avrebbe potuto prendere una strada diversa, se solo la Corte costituzionale avesse fatto leva su un altro aspetto della motivazione: quello relativo alla peculiarità della situazione regolata dalle disposizioni oggetto del giudizio.
Sono numerosi i passaggi argomentativi che sottolineano questo profilo: si parla di situazione fattuale «innegabilmente infrequente», di «peculiare fattispecie» non «semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso». Perché allora non impostare il ragionamento nei termini di regola-eccezione, consentendo – solo per questa specifica e peculiare ipotesi – di proseguire lo status matrimoniale (attraverso una sentenza manipolativa che sostituisse il divorzio automatico con un divorzio a domanda)? Se è vero, infatti, che ci troviamo di fronte ad un caso del tutto singolare, caratterizzato dall’esistenza, sul piano giuridico, di «un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale», perché non considerare questo caso una possibile eccezione alla regola dell’eterosessualità del matrimonio? Forse per il timore che ciò possa costituire comunque un primo passo verso una più ampia messa in discussione di quella regola? E questo ipotetico timore può davvero giustificare l’applicazione di disposizioni normative che privano i coniugi dello stato di «massima protezione giuridica» assicurato dal matrimonio (per precipitarli oggi in una condizione «di assoluta indeterminatezza», e domani, forse, per relegarli in un’ «altra forma di convivenza registrata», comunque diversa dall’istituto matrimoniale)?
E arriviamo ad un’ultima osservazione. Il criterio utilizzato dalla Corte, quello del controllo di ragionevolezza delle differenziazioni operate dal legislatore, conduce in questo contesto ad una inevitabile frammentazione delle tipologie familiari, all’adozione, cioè, di misure legislative peculiari per ciascuno dei gruppi sociali considerati. Lo ha sottolineato molto bene Antonio Ruggeri, osservando che «accanto alla famiglia in senso stretto (o strettissimo), quella definita nell’art. 29 Cost., nella interpretazione datane dalla Corte, avremo delle unioni “parafamiliari”, composte da soggetti (omosessuali o eterosessuali che siano) che non abbiano avuto un “pregresso vissuto” familiare, quale quello caratterizzante i soggetti protagonisti della odierna vicenda, e, ancora distinta da tali unioni, una speciale (o specialissima) formazione sociale che potremmo chiamare “quasi familiare” (o “familiare” minus quam perfecta), risultante dai soggetti stessi» [A. Ruggeri, Questioni di diritto di famiglia e tecniche decisorie nei giudizi di costituzionalità (a proposito della originale condizione dei soggetti transessuali e dei loro ex coniugi, secondo Corte cost. n. 170 del 2014) (13.06. 2014), in www.giurcost.org, 5]. Una prospettiva, a mio avviso, da evitare, perchè rischia di produrre inaccettabili diseguaglianze; un’idea di società che nulla ha che fare con la modernità e i suoi valori di liberazione dell’individuo, e che incarna piuttosto una post-modernità regressiva e discriminatoria, di cui si avvertono ormai molti segnali.
(*) Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico
Università di Ferrara
[whohit] BRUNELLI divorzio imposto [/whohit]