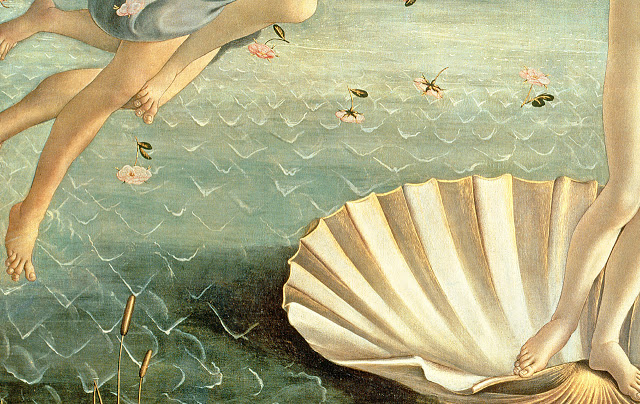Surrogazione: per la Corte di Giustizia non c’é diritto al congedo di maternitá
| 26 marzo, 2014 | Filled under genitorialità, OPINIONI |
|
Con due recenti pronunce, la Corte di giustizia ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di riconoscere un diritto al congedo di maternità a una madre affidataria di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata. In tal modo, la Corte sembra avere fatto proprio un approccio piuttosto restrittivo, inusuale nella sua tradizionale giurisprudenza, in particolare quando vengano in considerazione diritti di fonte Ue.
With two recent judgments, the European Court of justice has held that EU Law doesn’t provide for a maternity leave for the intended mother of a child born following a surrogacy agreement. In this way, the Court seems to have adopted a particularly restricted approach, unusual in its traditiional jurisprudence, especially when EU rights are at stake.
di Marco Balboni*
1. Con due recenti pronunce, la Corte di giustizia Ue ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di riconoscere un diritto al congedo di maternità a una madre affidataria di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata (madre committente nel linguaggio della Corte) [1]. La Corte ha così accolto nella sostanza le motivazioni di uno degli Avvocati generali, respingendo quelle più possibiliste dell’altro [2].
Come si ricorderà, seppure con qualche variazione in ragione delle particolarità di ciascun caso, a essere invocate a fondamento della comune pretesa erano la direttiva 92/85 sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la direttiva 2006/54 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la direttiva 2000/78 relativa a un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro in ragione, tra l’altro, del motivo della disabilità, unitamente alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.
2. La Corte esclude che la direttiva 92/85 sia interpretabile nel senso che una madre affidataria abbia diritto al congedo di maternità di cui all’art. 8 della direttiva, anche nel caso in cui effettivamente allatti o comunque possa allattare al seno il bambino [3]. La Corte perviene a tale risultato dando prevalenza, in sostanza, al criterio di interpretazione testuale – letterale su quello teleologico.
Ai sensi dell’art. 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici fruiscano di un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il “parto”, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
La Corte ricorda l’importanza del diritto previsto da tale disposizione e, in particolare, il duplice scopo che esso persegue e cioè quello di garantire, da un lato, la difesa della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza e, dall’altro, la protezione delle particolari relazioni tra la donna e il suo bambino durante il periodo successivo alla gravidanza e il parto, evitando che tali relazioni siano turbate dal cumulo degli oneri derivanti dal contemporaneo svolgimento di un’attività lavorativa.
Con il caso in esame, essa rifiuta di adattare questa giurisprudenza alla condizione specifica della madre affidataria. Secondo la Corte, infatti, la seconda finalità, quella relativa alla protezione della relazione tra madre e bambino, non può superare il dato letterale della giurisprudenza precedente, derivante dal testo di cui all’art. 8, secondo cui essa può riguardare “soltanto il periodo successivo alla gravidanza e il parto” e, quindi, può interessare soltanto le donne che siano state incinta o abbiano partorito [4].
In tal modo, la Corte respinge le sollecitazioni di uno dei due Avvocati generali che aveva invece considerato la possibilità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva reinterpretandone il testo alla luce delle mutate condizioni storiche rispetto a un’epoca in cui il fenomeno della surrogazione non poteva essere certo presente all’attenzione del legislatore. In particolare, secondo l’Avvocato generale, la direttiva doveva almeno comprendere la madre affidataria che allatta dato che le donne che allattano al seno sono una categoria espressamente contemplata dalla direttiva in esame e non c’è alcun motivo per ritenere che le madri affidatarie che allattano si trovino in una posizione tanto diversa dalle madri biologiche che facciano altrettanto, che tuttavia limitare l’applicazione della direttiva a tale categoria di madri affidatarie significa dare rilievo a un aspetto, l’allattamento, del tutto eventuale nella relazione tra madre e figlio, che in fondo la madre biologica che non allatta non per questo è privata del congedo di maternità, che tutto considerato e più in generale la madre affidataria non è in una posizione tanto diversa da quella della madre biologica almeno a partire dal momento in cui assume la custodia del figlio e che, infine, l’esigenza di salvaguardare la relazione tra madre e figlio è forse addirittura più forte per la madre affidataria dato che si tratta in questo caso di stabilire tale relazione ex novo e dal principio [5].
In realtà, la definizione dello scopo della direttiva e, quindi, la delimitazione del suo campo di applicazione ratione personae non può essere stabilito correttamente se non ci si interroga sul senso del termine “parto” previsto dall’art. 8 e reiterato nella giurisprudenza successiva.
Se con il termine in esame ci si intende riferire all’evento che in sé e per sé interessa il corpo della donna, allora l’interpretazione restrittiva si impone, ma ha poco senso porsi il problema di estendere lo scopo della direttiva alla dimensione relazionale tra madre e figlio. Si rimane confinati in una sfera meramente biologica che ruota attorno esclusivamente alla donna che partorisce, la cui posizione è effettivamente unica, non assimilabile a quella di nessun altro e perciò esclusiva.
Se invece con il termine parto ci si intende riferire all’evento della nascita, che sarebbe l’unico senso possibile se si vuole ricomprendere nella direttiva lo scopo di favorire la dimensione relazionale, allora, a partire da quell’evento non c’è motivo di fare differenze tra chiunque venga a trovarsi in una relazione particolare con il neonato in ragione e come conseguenza della nascita. Una tale differenza finisce con l’essere una discriminazione di cui si fatica a trovare la giustificazione e che, come aveva osservato l’A.G., si ripercuote a danno dei figli [6].
Ora, come è stato detto, se si assume una visione complessiva della genitorialità, ciò che distingue il congedo di maternità da altri congedi sta “nel fatto stesso della nascita, considerata come evento puntuale” e nelle sue inevitabili conseguenze [7]. Per questa ragione, non c’è nessun motivo di temere una possibile estensione all’infinito del congedo di maternità, come la Corte sembra fare, anche se, naturalmente, una certa estensione sarà necessaria a favore di tutti i genitori affidatari, maschi o femmine, transgender o intersex. Per lo stesso motivo, il congedo appropriato per i genitori affidatari non può che essere quello di maternità e non quello di adozione.
La restrizione operata dalla Corte sembra quindi criticabile in quanto limitata a una visione ristretta della dimensione del parto e di quanto a essa si collega. Essa non appare inevitabile, anche se un adeguamento normativo è certamente auspicabile (ancorché difficile) [8].
Quanto sin qui detto non significa affatto pronunciarsi sull’ammissibilità o meno della surrogazione che rimane una questione eticamente sensibile di competenza degli Stati membri, ma solo sull’estensione uniforme di un diritto di fonte Ue. Le due questioni quindi non vanno confuse con la conseguenza che l’una non deve attrarre l’altra nella propria orbita. L’eventuale obbligo Ue di riconoscere il congedo, quindi, non può che riguardare i casi in cui la surrogazione è lecita per il diritto rilevante (perché ammessa dallo Stato de quo o perché realizzata in regime transfrontaliero), mentre più difficile ovviamente è l’estensione dell’obbligo nei casi in cui la surrogazione sia praticata all’interno di uno Stato che la vieta, anche se la situazione di custodia di fatto del bambino dovrebbe comunque prevalere.
Sembra pertanto non cogliere lo spirito profondo della direttiva l’affermazione della Corte secondo cui la direttiva Ue non obbliga, ma facoltizza soltanto gli Stati membri a prevedere un congedo di maternità per i genitori affidatari in linea con il fatto che la direttiva persegue lo scopo di stabilire prescrizioni minime [9]. Di certo, la direttiva mira a stabilire un quadro minimo, ma non appare corretto ricostruire tale quadro senza tenere conto di quanto può essere ricavato, sia pure in via interpretativa, dallo stesso articolato normativo della direttiva.
3. La Corte esclude altresì che sia applicabile al caso di specie la direttiva 2006/54 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego [10]. Se condivisibile nei risultati, la motivazione adotta non è tuttavia sempre cristallina.
Certamente, come la Corte osserva, non si può ritenere che il mancato riconoscimento del congedo a una madre affidataria possa essere considerato una discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso, entrambe vietate dalla direttiva. Tale mancato riconoscimento infatti non colpirebbe in modo diverso il padre affidatario.
Più problematico quanto affermato dalla Corte in relazione al divieto di discriminazione stabilito dall’art. 2 par. 2 della direttiva ai sensi del quale la discriminazione comprende qualsiasi trattamento meno favorevole riservato a una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85.
Secondo la Corte, tale normativa non è applicabile al caso di specie perché non c’è gravidanza e, in base a quanto sopra rilevato, non c’è diritto al congedo di maternità. Se l’assenza di gravidanza è certamente una ragione sufficiente, altrettanto non si può dire per l’altra motivazione, e cioè per il fatto che manca un diritto al congedo. La ragione, infatti, per cui l’art. 2 par. 2 non è applicabile al caso di specie non risiede in questo dato, di cui la normativa in esame non si occupa, essendo il diritto previsto dalla direttiva 92/85, ma nella portata della disposizione stessa. Essa, infatti, fa riferimento ai casi in cui un trattamento meno favorevole sia collegato al godimento del diritto del congedo, come ad esempio nell’ipotesi in cui il trattamento deteriore sia inflitto a una persona al rientro sul lavoro dopo averne usufruito, e non al riconoscimento in sé e per sé del diritto [11].
Il legame stabilito dalla Corte tra inapplicabilità della disposizione e assenza del diritto al congedo finisce in realtà per impoverire ulteriormente il contenuto protettivo della direttiva in esame perché sembra escluderne la portata precettiva anche nei casi in cui il diritto al congedo di cui alla direttiva 92/85 sia stato previsto dal diritto nazionale, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dalla stessa Corte agli Stati membri. Almeno con riferimento a quest’ultima categoria di ipotesi, infatti, non c’è alcun motivo per escludere che l’art. 2 par. 2 possa trovare piena applicazione, ricorrendone i presupposti.
L’interpretazione in esame è avallata anche dalla formulazione dell’art. 16 della direttiva in esame ai sensi del quale quest’ultima “lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riconoscere diritti distinti di congedo di paternità e di adozione”. Tuttavia, se riconoscono diritti di questo tipo, gli Stati membri sono tenuti a adottare “le misure necessarie per tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro il licenziamento causato dall’esercizio di tali diritti e per garantire che alla fine di tale periodo di congedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno favorevoli” oltre che di “beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante la loro assenza”.
Come osserva la Corte, la disposizione lascia inalterata la libertà degli Stati membri di accordare o meno un congedo di adozione. Un tale diritto, del resto, non è riconosciuto da nessun’altra norma di diritto Ue, il che implicitamente conferma quanto si diceva sopra e cioè che congedo di adozione e congedo di maternità hanno causa e natura diversa. Tuttavia, la ragione per cui la norma in esame è irrilevante nel caso di specie non sta tanto nel fatto in sé di non prevedere un diritto al congedo per adozione, ma nel fatto che si concentra sulle discriminazioni derivanti dal godimento di tale diritto. Pertanto, se uno Stato membro dovesse riconoscere un congedo di adozione a una madre affidataria, come lo stesso testo della norma conferma, non c’è ragione per non applicare quest’ultima al caso di specie, qualora ne dovessero ricorrere i presupposti.
4. Infine, la Corte esclude l’applicabilità anche della direttiva 2000/78 [12]. Anche in questo caso, l’esclusione appare in linea di principio corretta nei risultati, ma criticabile nella motivazione. La Corte, infatti, esclude tale applicazione in ragione della nozione di handicap da essa accolta più che in ragione del tipo di misura richiesta.
La Corte ricorda che la nozione di handicap accolta dalla direttiva, così come interpretata alla luce della pertinente Convenzione delle Nazioni unite, si riferisce a una limitazione, risultante in particolare da durature menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Essa non si riferisce soltanto a un’impossibilità di esercitare un’attività professionale, ma anche a ostacoli a svolgere una simile attività. Se l’assenza dell’utero e lo stress legato all’incapacità di procreare che ne consegue possono essere ritenuti in generale un handicap, essi, tuttavia, non lo sarebbero ai sensi della direttiva. Tali patologie, infatti, non costituiscono di per sé, almeno in via di principio, impedimenti a accedere a un impiego, a svolgerlo o ad avere una promozione.
Una tale nozione sembra tuttavia eccessivamente limitativa e tutto sommato contraddittoria. In realtà, infatti, la Corte sembra dimenticare gli aspetti sociali legati alla vita professionale che pure il richiamo alla Convenzione Onu dovrebbe aiutare a porre in rilievo. Se è vero che l’handicap costituisce un’interazione tra la propria menomazione e le barriere di diversa natura presenti nel contesto in cui ci si trova, è anche vero che occorre tenere conto degli ostacoli che l’ambiente di lavoro può porre a una persona che si trova nella situazione della ricorrente, che nel caso di specie fanno riferimento soprattutto alla sfera mentale e emotiva (capacità di gestire situazioni complesse, ritmo di lavoro, pressione competitiva, ecc.). L’incapacità di affrontare questi aspetti non è scindibile dall’incapacità di affrontare la vita professionale. Affermare il contrario significherebbe ridurre la nozione di handicap alla sola mancanza delle abilità fisico-tecniche con una notevole limitazione dell’ambito di applicazione delle misure protettive previste dalla direttiva.
Vero è, come osserva la Corte, che “nel caso in esame, dalla decisione del rinvio non risulta che la patologia di cui soffre la sig.ra Z. le abbia impedito di svolgere il suo lavoro o abbia ostacolato l’esercizio della sua attività professionale”. La Corte sembra quindi attenuare il rigore delle affermazioni precedenti, ammettendo, in linea di principio, che anche una patologia come quella in esame possa rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva, qualora ricorrano determinati elementi. Anziché limitarsi all’affermazione in esame, tuttavia, sarebbe stato preferibile che la Corte avesse rimandato la questione allo stesso giudice nazionale, invitandolo ad accertare se nel caso di specie tali elementi ricorrevano o meno e, in caso positivo, a ritenere integrata la nozione di handicap prevista dalla direttiva.
Se questo è vero, in realtà, il punto sembra un altro e cioè che la misura richiesta non sembra costituire una di quelle misure cui la direttiva si riferisce. Al congedo di maternità, infatti, difficilmente può essere assegnata la funzione di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in ragione della disabilità e, quindi, esso non sembra costituire una di quelle misure ragionevoli cui la direttiva obbliga il datore di lavoro a questo scopo.
5. In definitiva, non sempre convincente nella motivazione, la decisione della Corte non convince sicuramente anche nei risultati, in particolare in relazione all’interpretazione della direttiva 92/85. Essa sembra risentire di una certa prudenza nell’interpretazione della direttiva che rivela un atteggiamento molto diverso da quello tradizionale da essa assunto in particolare quando si tratta di ricostruire il nucleo forte dei diritti dei cittadini Ue.
In tal modo, la Corte sembra alimentare l’impressione di essere incline a dare prevalenza a un certo margine di apprezzamento degli Stati sull’esigenza di assicurare l’effetto utile e l’interpretazione uniforme del diritto Ue quantomeno quando vengano in considerazione questioni eticamente sensibili. Si tratterebbe di un atteggiamento simile a quello mantenuto in molti casi dalla Corte europea dei diritti umani ma che, nel diverso quadro dell’ordinamento giuridico dell’Ue, sembra trovare molta meno giustificazione e, in ogni caso, essere in contraddizione con l’approccio tradizionale assunto nella materia.
[1] Corte di giustizia, 18 marzo 2014, caso C.D. c. S.T., causa C-167/12 e caso Z. c. A Government Department and the Board of Management of a Community School, causa C-363/12.
[2] M. Balboni, Gli Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea e la surrogazione di maternità, in www.articolo29.it , cui si rimanda per più ampi riferimenti e per le indicazioni relative agli strumenti normativi citati.
[3] Corte di giustizia, caso C.D. c. S.T., cit., p. 28 ss.
[4] Secondo la Corte, rafforza questa conclusione la sua giurisprudenza precedente con cui aveva ritenuto che per beneficiare del divieto di licenziamento delle lavoratrice nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all’art. 10 della direttiva 92/85 la gravidanza “deve aver avuto inizio”: Corte di giustizia, 26 febbraio 2008, caso Mayr, causa C-506/06, in Raccolta, I-1017, p. 37. In realtà, se la posizione di una donna la cui gravidanza non abbia avuto inizio non è certamente equiparabile a quella di una donna incinta, difficilmente si può dire lo stesso di una madre affidataria che ha la custodia di un bambino neonato e quella di una madre biologica in congedo di maternità. La prima viene a trovarsi in una posizione di vulnerabilità rispetto alla seconda che nuovamente non sembra giustificata alla luce della loro condizione rispettiva.
[5] Conclusioni A.G. J. Kokott, caso C.D. c. S.T., causa C-167/12, p. 35 ss.
[6] Id., cit., p. 45.
[7] Conclusioni A.G. A. Tizzano, sentenza del 14 aprile 2005, caso Commissione c. Lussemburgo, causa C-519/03, in Raccolta, p. I-3067 ss., p. 72.
[8] In questo senso, cfr., invece il comunicato del LGBT Intergroup del Parlamento europeo, Court of Justice: EU law does not guarantee maternity leave for mothers using surrogacy, 19 marzo 2014. Appare in particolare criticabile la dichiarazione di R. Romeva i Rueda, vice-presidente dell’Intergruppo, secondo cui “the court is technically right, since neither woman was pregnant or adopted her child. EU law is clear that minimum standards of protection apply to those women only”.
[9] Cfr., considerando 1 della direttiva.
[10] Corte di giustizia, caso C.D. c. S.T., cit., p. 44 ss.; caso Z. c. A Government Department and the Board of Management of a Community School, cit., p. 46 ss.
[11] Cfr., art. 15 della direttiva.
[12] [12] Corte di giustizia, caso Z. c. A Government Department and the Board of Management of a Community School, cit., p. 68 ss.
______________________________________
[whohit]BALBONI CGE surrogacy marzo 2014[/whohit]