Gli Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea e la surrogazione di maternità
| 1 dicembre, 2013 | Filled under genitorialità, OPINIONI, orientamento sessuale, unione europea |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di due madri affidatarie di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata di beneficiare del diritto al congedo di maternità, come previsto dal diritto dell’Unione. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, si sono già espressi i due avvocati generali, con opinioni tuttavia contrastanti. In gioco, sembra esserci non solo l’istituto della surrogacy, ma anche il senso e la funzione del congedo di maternità.
di Marco Balboni*
Il caso
Due giudici di due Stati membri dell’Unione europea hanno sollevato alcune questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia al fine di sapere se il diritto dell’Unione impone il riconoscimento del diritto al congedo di maternità a favore dei genitori del bambino nato in seguito a un contratto di maternità surrogata. La questione è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ma su di essa si sono già pronunciati i due Avvocati generali nei due rispettivi procedimenti. Mentre secondo l’Avvocato generale Wahl un tale diritto non può essere invocato in base al diritto dell’Unione (causa C-363/12, caso Z c. un Ministero ed il consiglio di amministrazione di una Comunity School – Conclusioni dell’avvocato generale), secondo l’Avvocato generale Kokott, almeno in caso di maternità surrogata legalmente effettuata, sia la madre surrogata che la madre affidataria hanno diritto al congedo di maternità (causa C-167/12, caso CD c. ST – Conclusioni dell’avvocato generale). Al di là di alcune differenze, i due casi pongono problemi sostanzialmente identici. Può quindi sorprendere la differenza di opinioni, come si vedrà dovuta essenzialmente a argomenti ermeneutici diversi. Vale la pena soffermarsi su di essi, anche in ragione delle implicazioni che la decisione può avere oltre il caso di specie.
Il primo caso (caso Z) riguarda una signora irlandese che soffre di una rara patologia per effetto della quale, pur avendo ovaie funzionanti ed essendo quindi fertile, è priva dell’utero e non è in grado di sostenere la gravidanza. Al fine di potere avere un figlio, la Sig.ra Z e il coniuge hanno stipulato un contratto di surrogazione in California la cui legislazione non prevede la menzione della madre surrogata nel certificato di nascita. Mentre disciplina i congedi di maternità e di adozione retribuiti, la legislazione irlandese non contiene alcuna disciplina riguardante il congedo in caso di nascita di un figlio in seguito a un contratto di maternità surrogata, né tale disciplina è stata prevista nel contratto di lavoro della Sig.ra Z. Il secondo caso riguarda CD e il proprio compagno, entrambi residenti nel Regno unito. In questo caso, sono stati utilizzati gli spermatozoi del compagno ma non gli ovociti di CD. Al contrario di Z, quindi, CD non è madre biologica del bambino. CD, tuttavia, ha iniziato a occuparsi del bambino e allattarlo già un’ora dopo la nascita. Al contrario di quella irlandese, la legislazione inglese disciplina la maternità surrogata. Tale legislazione riconosce in linea di principio come genitore la madre surrogata, indipendentemente dal fatto che sia o meno la madre genetica. Tuttavia, su richiesta dei genitori affidatari, il giudice può disporre un provvedimento di attribuzione della potestà genitoriale (parental order) in base al quale il bambino viene considerato figlio dei richiedenti a condizione, tra l’altro, che siano stati impiegati i gameti di almeno uno di essi, che tra i richiedenti esista un vincolo coniugale o equiparabile e che la madre surrogata presti il proprio accordo.
In entrambi i casi, sono invocate la direttiva 92/85 sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento [1] e la direttiva 2006/54 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego [2], mentre (comprensibilmente) soltanto nel primo caso è invocata anche la direttiva 2000/78 relativa a un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro in ragione, tra gli altri, del motivo della disabilità [3], unitamente alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Unione europea [4].
La direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale sulla parità di trattamento e il profilo della disabilità
Mentre la convenzione delle Nazioni unite accoglie una nozione sociale di disabilità secondo cui quest’ultima nasce dall’incapacità del contesto sociale di conformarsi e di rispondere alle esigenze di persone che presentano menomazioni [5], la direttiva non definisce la nozione di disabilità [6].
Quest’ultima è stata tuttavia oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia. La Corte ha sottolineato la necessità di accogliere una nozione autonoma di disabilità in ambito Ue, al fine di garantire non solo l’applicazione uniforme del diritto Ue, ma anche il rispetto del principio di parità di trattamento tra le persone sottoposte alla sua giurisdizione. In un primo tempo, tuttavia, essa ha definito la nozione di disabilità in senso restrittivo, come risultato di minorazioni fisiche, mentali o psichiche che ostacolano la partecipazione alla vita professionale [7]. Tale interpretazione è mutata in seguito alla ratifica della convenzione delle Nazioni unite da parte della Ue. Più recentemente, infatti, la Corte ha riconosciuto che il concetto di disabilità costituisce una nozione in evoluzione e che quest’ultima, allo stato attuale del diritto Ue, ricomprende ogni limitazione risultante da menomazioni durature di natura fisica, mentale o psichica che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena e effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori [8]. La Corte ha così accolto la dimensione sociale presente nella convenzione delle Nazioni unite, anche se, in ragione dell’ambito di applicazione della direttiva, ne ha circoscritto il rilievo alla partecipazione alla vita professionale e non in senso ampio alla vita sociale.
Secondo l’A.G., una patologia come quella di cui soffre la ricorrente nella causa Z può senz’altro rientrare nel concetto di disabilità così precisato. Infatti, tale patologia è certamente “una fonte di grande tensione” per la ricorrente tenuto conto del suo desiderio di avere un figlio. Ne deriva che tale menomazione può effettivamente ostacolare la partecipazione piena e effettiva alla vita sociale come indicato dalla convenzione ONU. Se questo è vero, tuttavia, difficilmente la limitazione in esame può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva. Infatti, a causa del carattere intrinsecamente contestuale della disabilità, la questione di cosa costituisca disabilità ai sensi della direttiva deve tenere conto della ratio dell’atto in esame, che riguarda la lotta alla discriminazione nel contesto specifico dell’impiego al fine di consentire alla persona disabile di avere accesso e di partecipare al mercato del lavoro. Per quanto ingiusta possa essere percepita l’incapacità di avere un figlio per via naturale, il contesto normativo dell’Unione non può essere interpretato nel senso che si estenda a situazioni non correlate alla capacità lavorativa della persona. Occorre, infatti, stabilire una relazione tra limitazione e capacità lavorativa affinché la limitazione in questione possa essere ricompresa nella portata della direttiva. Ora, nel caso di specie, una tale relazione non vi sarebbe dato che non si potrebbe dire che la patologia di cui la ricorrente soffre impedisca la sua partecipazione alla vita professionale.
Questa argomentazione dell’A.G. non convince. Essa infatti non sembra cogliere correttamente le implicazioni sociali del concetto di disabilità come definito dalla convenzione delle Nazioni unite e come riconosciuto dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia, limitandosi a intendere la partecipazione alla vita professionale come capacità in senso stretto di svolgere una attività lavorativa.
In effetti, se la disabilità non è rappresentata dall’incapacità di avere figli di per sé, ma dalla tensione che tale incapacità può generare nella persona che desidera avere un figlio, è altrettanto chiaro che tale tensione, nella misura in cui può costituire un ostacolo alla partecipazione effettiva alla vita sociale, può costituire altresì un ostacolo alla partecipazione effettiva alla vita professionale. Esiste infatti un nesso imprescindibile tra vita professionale e vita sociale. La partecipazione alla vita professionale implica anche la partecipazione a tutta una serie di aspetti sociali che sono correlati all’ambiente di lavoro, dalla capacità di recarsi al lavoro alla capacità di starci in modo appropriato alla capacità di affrontare emotivamente le responsabilità che esso implica, per quanto ridotte possano essere. Il ragionamento dell’A.G. appare pertanto da rimodulare. Se è vero che appare difficile considerare in se stessa l’incapacità di avere figli come una disabilità (piuttosto che come una patologia), certamente tale può essere la tensione emotiva che si può accompagnare a una tale situazione. Per sua natura, tale tensione può dare luogo non solo a una disabilità sociale in senso lato, ma anche professionale, se si considera la dimensione sociale del lavoro. Essa, inoltre, può toccare chiunque venga a trovarsi in una situazione simile a quella della ricorrente, quale che sia la causa all’origine dell’incapacità di avere figli. Non c’è ragione infatti di limitare la nozione di disabilità alla tensione causata dall’incapacità di avere figli in ragione di particolari patologie. Anche una persona LGBTI, ad esempio, potrebbe soffrire di una tensione del genere.
Contrariamente a quanto sembra ritenere l’A.G., pertanto, non è tanto in gioco l’ambito di applicazione della direttiva, che potenzialmente sussiste, quanto la stessa nozione di disabilità.
Nonostante la reinterpretazione di cui sopra, è dubbio che la direttiva possa essere di qualche utilità per il diritto al congedo di maternità. Essa infatti non stabilisce un diritto al congedo di maternità per genitori disabili, ma si limita a imporre al datore di lavoro di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in ragione della disabilità mediante l’adozione di soluzioni ragionevoli, in relazione a ciascun caso concreto, al fine di consentire ai disabili l’accesso al lavoro, di svolgerlo e/o di avere una promozione o una formazione, a condizione peraltro che le soluzioni in esame non determinino un onere finanziario sproporzionato per lo stesso datore di lavoro (art. 5).
Secondo l’A.G., una tale soluzione non potrebbe essere costituita dal congedo di maternità e, più in generale, da qualsiasi misura che implichi un congedo, in particolare se retribuito. Il congedo, infatti, sarebbe una misura molto diversa dalla riduzione dell’orario di lavoro, ritenuta dalla Corte ragionevole ai sensi del citato art. 5 [9]. A differenza di quest’ultima, infatti, non sarebbe determinata dalla necessità di garantire l’accesso al lavoro, ma dalla decisione della ricorrente di fare ricorso alla maternità surrogata, mancando quindi di qualunque nesso con le finalità della direttiva [10]. Inoltre, ammesso che rientri nelle finalità di quest’ultima, darebbe luogo a un onere eccessivamente sproporzionato per il datore di lavoro, il quale potrebbe essere tenuto al massimo a un congedo non retribuito [11].
Se l’argomento in esame può essere accettato per il congedo di maternità, dato che la finalità della direttiva è quella di rimuovere le discriminazioni in ragione anche della disabilità e non quella di proteggere la maternità o di rimuovere le discriminazioni in ragione di questo aspetto, difficilmente l’argomento dell’A.G. sembra accettabile in generale. Anche a prescindere da ogni considerazione riguardante la socializzazione dei costi della disabilità, un congedo motivato da ragioni di questo tipo sembra benissimo giustificarsi per consentire il ritorno del disabile sul posto di lavoro, almeno nel caso in cui ricorrano determinate condizioni. Per la stessa ragione, non sembra sproporzionato che il datore di lavoro ne sopporti in parte gli oneri, dato che il congedo può avere per l’appunto la finalità di consentire il ritorno al lavoro e quindi essere collegato a quest’ultimo.
La direttiva 2006/54 sulla parità di trattamento tra uomini e donne
La direttiva 2006/54 costituisce la rifusione di una serie di direttive precedenti in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui in particolare la direttiva 76/207/CEE relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento in materia di lavoro [12].
L’analisi della direttiva in esame non diverge: entrambi gli Avvocati generali sono dell’avviso che essa non è applicabile al caso di specie, sia per quanto riguarda il par. 1 che 2 dell’art. 2 della stessa.
L’art. 2 par. 1 vieta le discriminazioni sia dirette che indirette in base al sesso. Come osserva l’A.G. Kokott, tuttavia, la ricorrente non ha subito svantaggi rispetto ai colleghi maschi a causa del sesso, ma, semmai, per avere realizzato il suo desiderio di maternità con l’aiuto di una madre surrogata. La disparità di trattamento non è quindi basata sul sesso, ma sul diniego da parte delle autorità nazionali di assimilare la situazione di una madre affidataria a quella di una puerpera o di una madre adottiva. Come osserva l’A.G. Wahl, anche un genitore maschio di un figlio nato mediante maternità surrogata, con tutta probabilità, non sarebbe stato trattato diversamente [13].
Se questo è vero, rimane da vedere quale potrebbe essere il termine di paragone per un eventuale giudizio di comparazione. Mentre l’A.G. Kokott sembra assimilare le madri che hanno effettuato ricorso alla surrogazione alle madri che non vi hanno fatto ricorso [14], l’A.G. Wahl sembra propendere per assimilare le prime alle madri adottive e, più in generale, a tutti i genitori, siano essi uomini o donne, che non hanno dato alla luce un figlio [15]. Le due impostazioni sono molto diverse: la prima tende a non ravvisare differenze con la posizione in cui si trovano le donne in seguito alla nascita di un figlio cui hanno dato la luce, ancorché limiti l’analisi alle sole donne; la seconda tende a non ravvisare differenze rispetto ai genitori che non hanno dato alla luce un bambino, ancorché estenda l’analisi anche ai genitori di sesso maschile. Benché più ampia della prima, quest’ultima posizione non porterebbe molto lontano nel quadro del diritto Ue. Quest’ultimo infatti non prevede un diritto simile al congedo di maternità né per i genitori adottivi né per quelli che non hanno dato alla luce un figlio, limitandosi a stabilire a favore di questi ultimi il diritto al congedo parentale, la cui disciplina è meno solida del congedo di maternità [16], e l’obbligo per gli Stati membri di evitare conseguenze sfavorevoli al rientro sul luogo di lavoro per chi si sia avvalso di un congedo di adozione o di paternità riconosciuto dal diritto interno [17].
L’art. 2 par. 2 vieta altresì la discriminazione per motivi collegati alla gravidanza e al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE. Ancorché la giurisprudenza tradizionale della Corte non richieda la necessità di una comparazione per rilevare discriminazioni vietate dalla norma in esame [18], entrambi gli A.G. concordano sul fatto che la stessa non sia applicabile al caso di specie. Il trattamento meno favorevole lamentato dalla madre affidataria infatti non è legato al fatto di essere o divenire gestante né al riconoscimento di un congedo di maternità. Quest’ultima ipotesi, regolata dall’art. 15 della direttiva, si verificherebbe qualora un congedo di maternità sia stato effettivamente concesso e ne siano derivati trattamenti sfavorevoli in seguito al rientro sul luogo di lavoro. Essa, quindi, non riguarda la diversa questione del riconoscimento o meno del diritto in questione [19].
La direttiva 92/85 sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
L’interpretazione dei due Avvocati generali diverge invece per quanto riguarda la direttiva 92/85 sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Per comprendere tali motivazioni, occorre premettere qualche cenno sulla portata della direttiva in esame.
La portata della direttiva 92/85
L’art. 1 della direttiva stabilisce che la stessa ha per oggetto l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la cui definizione si ritrova all’art. 2. Per tali lavoratrici, l’art. 8 stabilisce un diritto a un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, di cui almeno due obbligatorie, ripartite prima e/o dopo il parto. L’art. 10 vieta il licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all’art. 8. L’art. 11 prevede il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di una indennità adeguata per il periodo di congedo [20].
Le misure in esame sono state oggetto di una copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia.
La Corte ha da tempo precisato che ogni discriminazione basata sullo stato di gravidanza dà luogo a una discriminazione diretta fondata sul sesso vietata dall’art. 2 della direttiva 76/207, ora 2006/54/CE, che, per definizione, non presuppone l’esistenza di un termine di confronto dato che la gravidanza e la maternità rappresentano una condizione specifica della donna [21]. In quanto discriminazione diretta, essa non ammette giustificazione alcuna, diversamente dalle discriminazioni indirette, che invece ammettono cause di giustificazione.
La Corte ha altresì specificato che il congedo di maternità ha lo scopo di proteggere sia la condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza, sia le particolari relazioni tra la donna e il bambino durante il periodo successivo alla gravidanza e il parto, evitando che queste relazioni siano turbate dal cumulo degli oneri derivanti dal contemporaneo svolgimento di un’attività lavorativa [22]. In particolare, quest’ultima finalità distingue il congedo di maternità dal congedo parentale, come previsto dal diritto dell’Unione, il quale è volto alla cura del bambino [23]. Il fondamento del diritto al congedo parentale infatti non risiede “nel fatto stesso della nascita, considerata come evento puntuale”, ma “nella necessità di assicurare un’assistenza ai figli in tenera età e quindi nell’intento di consentire ai genitori di dedicarsi al bambino, ovviamente una volta che questi sia nato e per il periodo ritenuto a tal fine necessario” [24]. Si tratta di una distinzione riflessa nella stessa direttiva istitutiva del congedo parentale, secondo la quale quest’ultimo “è distinto dal congedo di maternità” e è attribuito ai lavoratori di ambo i sessi affinché possano avere cura del bambino “per un periodo minimo di quattro mesi fino a un’età non superiore a 8 anni” [25]. Per lo stesso motivo, probabilmente, mentre la direttiva sul congedo di maternità non si estende sino a ricomprendere il congedo di adozione, la direttiva sul congedo parentale si applica anche a quest’ultimo.
In un solo caso, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla direttiva 92/85 con riferimento a questioni di medicina riproduttiva. Nel caso, si trattava di stabilire il momento a partire dal quale la gravidanza ha inizio al fine di stabilire la durata del periodo di divieto di licenziamento previsto dall’art. 10. La soluzione del caso di specie ha dato modo alla Corte di precisare che la direttiva in esame è applicabile anche alle ipotesi di medicina riproduttiva e che, in coerenza con la giurisprudenza precedente, il licenziamento di una donna che si è sottoposta a un trattamento di fecondazione in vitro dà luogo a una discriminazione diretta in base al sesso il cui accertamento non richiede l’individuazione di alcun termine di confronto dato che tale trattamento può riguardare soltanto le donne [26].
L’interpretazione della direttiva 92/85/CEE in relazione all’ipotesi della surrogazione
Come precisa l’A.G. Kokott, il tenore letterale della direttiva non esclude di per sé che essa si applichi almeno alle madri affidatarie in periodo di allattamento. L’art. 2 della direttiva menziona espressamente la lavoratrice in periodo di allattamento, espressione che di per sé appare applicabile anche a una madre affidataria che si trovi nella stessa situazione. Il problema riguarda i risultati cui possono condurre gli altri criteri interpretativi.
Il problema si pone innanzitutto per il criterio interpretativo logico-sistematico. Entrambi gli A.G. concordano sul fatto che il criterio in esame escluda qualsiasi riferimento a madri affidatarie. Disposizioni come l’art. 8 o come l’art. 10, infatti, che limitano rispettivamente il diritto al congedo al periodo “prima e/o dopo il parto” o la tutela dal licenziamento al periodo “tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità”, presuppongono necessariamente che le madri interessate siano solo quelle che hanno dato o devono dare alla luce un bambino. Come osserva l’A.G. Kokott, il criterio interpretativo in esame suffraga l’idea che la direttiva faccia riferimento unicamente a un concetto biologico-monistico di maternità che esclude che lavoratrice gestante e lavoratrice in periodo di allattamento possano essere due persone distinte.
Come osserva la stessa A.G. Kokott, tuttavia, tale criterio non può essere risolutivo. I risultati cui esso conduce sono largamente spiegabili alla luce del contesto storico in cui la direttiva è stata adottata, contesto in cui la maternità surrogata era tutt’altro che diffusa. Il problema non può essere risolto quindi senza ricorrere a un terzo criterio interpretativo e cioè al criterio teleologico [27]. Su quest’ultimo, tuttavia, la posizione dei due A.G. diverge.
Analogamente a quanto argomentato a proposito delle altre direttive, secondo l’A.G. Wahl, la direttiva in esame ha lo scopo di promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro proteggendo la condizione psico-fisica di una particolare categoria di lavoratrici. Tali sarebbero soltanto le donne che danno alla luce un figlio. Se è vero che la Corte ha considerato che, a differenza di quello parentale, il congedo di maternità ha lo scopo di proteggere anche le relazioni tra la donna e il bambino, è anche vero che tale riferimento non può essere inteso estensivamente, ma soltanto come logico corollario del parto e dell’allattamento. Se così non fosse, infatti, si dovrebbe concludere che la direttiva si estende anche alle madri adottive e, più in generale, a qualsiasi genitore che si occupi a tempo pieno del neonato. Sarebbe infatti contraddittorio estendere la protezione della direttiva a una lavoratrice che si avvale della maternità surrogata, ma non a una lavoratrice madre adottiva o a un padre che abbia fatto ricorso alla maternità surrogata o a altri mezzi.
Al contrario, secondo l’A.G. Kokott, non vi è motivo di non applicare la direttiva almeno a tutte le madri affidatarie in periodo di allattamento. Se è vero che la direttiva si propone la tutela della salute delle lavoratrici future madri e puerpere e che una madre affidataria non è esposta agli stessi rischi di queste ultime, è anche vero che la madre affidataria che allatta al seno non si trova in una condizione diversa da quella della madre biologica che faccia altrettanto. Inoltre, la finalità di proteggere la relazione tra madre e figlio durante il periodo immediatamente successivo alla gravidanza e il parto non può non applicarsi allo stesso modo tanto alla madre affidataria che a quella biologica. Anzi, essa tocca maggiormente proprio le prime le quali, a differenza delle seconde, non solo sono responsabili della custodia del bambino, ma si trovano anche di fronte all’esigenza di costruire un legame con esso, di integrarlo nella famiglia e di abituarsi al ruolo di madre. Infine, non vi è motivo di limitare la garanzia in esame alle sole madri affidatarie che effettivamente procedono all’allattamento. Il tipo di alimentazione, infatti, dipende da un insieme di fattori estranei alla volontà della madre. La stessa madre biologica mantiene il diritto al congedo anche nel caso in cui non allatti. Non vi è motivo di riservare alla madre affidataria un trattamento diverso tanto più che questa, in considerazione della divisione di compiti con la madre surrogata, può usufruire del congedo di maternità solo dopo la nascita. Attribuire un ruolo decisivo al tipo di alimentazione non garantirebbe la finalità di tutela, sancita a livello di diritti fondamentali, riguardante lo sviluppo indisturbato della relazione tra madre e figlio.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, quindi, la medicina riproduttiva ha superato, nel tempo, la struttura logico-sistematica della direttiva. Analogamente a quanto accadeva un tempo quando si ricorreva a una balia, il ruolo di madre nei casi di maternità surrogata è ripartito tra due donne, alle quali deve essere garantita la tutela prevista dalla direttiva per i periodi rispettivamente rilevanti per ciascuna di esse: la madre surrogata, che porta a compimento la gravidanza, pur non accudendo il bambino dopo la nascita, ha bisogno di essere tutelata in quanto lavoratrice gestante e puerpera; la madre affidataria, che ha la custodia del lattante e che eventualmente provvede all’allattamento, ha bisogno di tutela dopo la nascita del bambino. Il progresso medico, quindi, richiede di interpretare le finalità della direttiva non in senso biologico-monistico, ma funzionale. La madre affidataria risulta ricompresa dalla direttiva in quanto, in base a un accordo concluso con la madre surrogata, si sostituisce a quest’ultima e inizia a prendersi cura del bambino al posto e allo stesso modo della prima con la conseguenza che deve poter godere degli stessi diritti di cui avrebbe beneficiato la madre surrogata dal momento della sostituzione.
Tale interpretazione troverebbe conferma anche nella giurisprudenza precedente. Quest’ultima infatti implicherebbe che la madre affidataria possa avvalersi della tutela prevista dalla direttiva dal momento in cui abbia assunto la custodia del bambino dato che da tale momento si trova in una situazione paragonabile a quella della madre biologica [28]. Una tale interpretazione non sarebbe in conflitto con il fatto che la direttiva non prevede il congedo di maternità per le madri adottive dato che, a differenze di quelle surrogate, queste ultime non hanno avviato alcuna relazione con la madre biologica prima della nascita al fine di determinare la sorte del nascituro sicché la loro situazione non è assimilabile. Una soluzione contraria, del resto, sarebbe svantaggiosa per i figli della madre surrogata i quali sarebbero discriminati rispetto ai figli di una madre biologica che mantenga il suo ruolo anche dopo la nascita, in contrasto con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) che tutela l’interesse superiore del minore.
Ne deriva che, almeno nel caso in cui uno Stato membro riconosca la maternità surrogata e, quindi, la ripartizione funzionale del ruolo di madre tra due donne, alla madre affidataria devono essere riconosciuti gli stessi diritti della madre biologica [29].
In definitiva, mentre secondo l’A.G. Wahl non può applicarsi alle madri affidatarie in quanto altrimenti non vi sarebbe motivo di escluderne l’applicazione anche a altre categorie di genitori, secondo l’A.G. Kokott la direttiva in esame si applicherebbe anche a tali categorie di madri, almeno nel caso in cui il loro ruolo sia riconosciuto legalmente all’interno dello Stato. Una tale conclusione non implicherebbe alcuna conseguenza per le madri adottive e per i genitori maschi (e anche trans gender probabilmente), mentre rimarrebbe aperta la questione nel caso in cui la surrogazione non sia ammessa nello Stato di appartenenza e nelle ipotesi c.d. transfrontaliere [30].
La delimitazione dello scopo della direttiva
Se è vero che entrambi gli A.G. esprimono il loro disagio di fronte a una fattispecie non ricompresa originariamente dal legislatore auspicando così implicitamente l’intervento di quest’ultimo, è anche vero che tale intervento non sembra prossimo, mentre non vi è dubbio che il fenomeno della surrogazione stia prendendo sempre più piede, a prescindere dalla disciplina prevista dai singoli legislatori nazionali. Come il caso in esame dimostra, quindi, è sempre più probabile che il ricorso alla surrogazione ponga dei problemi applicativi prima che il legislatore Ue decida di intervenire o di adeguare la normativa. Il caso in esame merita quindi qualche considerazione, anche come stimolo a una riflessione più generale.
Il diritto Ue non è chiamato a pronunciarsi sulla surrogazione in quanto tale che, come fenomeno, rientra nella competenza degli Stati membri, ma soltanto sul diritto di una persona che si trova nella condizione di una madre affidataria di beneficiare o meno del congedo di maternità, diritto conferito da norme Ue. La soluzione adottata, quindi, quale che sia, non incide sul dibattito etico-politico riguardante la surrogazione, né sul fatto che questa debba essere o meno prevista negli Stati membri.
Al tempo stesso, nel caso in esame, la Corte di giustizia non è chiamata a pronunciarsi su un diritto rientrante nella competenza interna, rilevante sul piano Ue soltanto sul piano della non discriminazione. Al contrario, essa è chiamata a pronunciarsi su un diritto conferito direttamente dall’Unione. La soluzione pertanto dovrà essere la più possibile uniforme sul piano Ue, evitando di dare luogo, come nella giurisprudenza sulla non discriminazione, a situazioni a geometria variabile o a doppia velocità determinate dall’applicazione del principio (Ue) di non discriminazione a diritti rientranti nella competenza nazionale. Più precisamente, la soluzione in esame dovrà essere adottata tenendo conto unicamente degli scopi del diritto Ue, in particolare di quelli enunciati dalla direttiva, non assumendo invece rilievo considerazioni di carattere interno.
Come è generalmente ammesso, l’obiettivo del diritto Ue in relazione al congedo di maternità è quello di tutelare la donna prima e dopo il parto e di proteggere la relazione tra questa e il bambino nei primi momenti di vita di quest’ultimo, dopo la nascita. Se il fenomeno della surrogazione elimina per il genitore affidatario l’esigenza di tutela legata al parto, non certamente viene meno l’esigenza di proteggere la relazione tra genitore e figlio derivante dalla nascita. L’ambito di applicazione ratione personae della direttiva deve quindi essere coerente con lo scopo in esame. Lo spirito della direttiva e il suo effetto utile, infatti, verrebbero meno se fossero escluse dalla protezione categorie di persone che il legislatore non ha espressamente previsto solo perché non poteva materialmente farlo al momento in cui ha elaborato il testo. Al contrario, il perseguimento dello scopo e dell’effetto utile della direttiva impone di tenere conto di tutte le persone che vengano a trovarsi via via in una situazione rilevante sotto il profilo della stessa.
In ragione di quanto detto, non vi è quindi alcun motivo per escludere dalla protezione della direttiva la madre affidataria, la madre cioè che si prenda cura del bambino dal momento della nascita sulla base di un accordo intervenuto con la madre surrogata.
Allo stesso modo, non sembra che vi sia alcun motivo per escludere da tale protezione anche il genitore affidatario maschio o transgender che assuma il medesimo ruolo dal momento della nascita. La posizione di entrambi infatti non sembra strutturalmente diversa da quella della madre affidataria. Ancorché dal punto di vista letterale deponga in senso contrario, l’uso del femminile nella direttiva non può ostacolare tale risultato così come il ricorso al maschile non fa altrettanto in casi ben più numerosi. Anche qui si tratta solo del riflesso di un uso linguistico che risente degli strumenti culturali e tecnici a disposizione in un determinato momento storico, ma che non necessariamente riflette lo scopo che il legislatore intendeva perseguire elaborando lo strumento.
Al contrario, non vi è motivo di ritenere che siano venute meno le ragioni che hanno indotto il legislatore a escludere dalla protezione il genitore adottivo. La ragione per cui il legislatore non ha esteso al tempo il congedo di maternità all’adozione sta nel fatto che quest’ultima e la situazione della nascita non sono comparabili, quantomeno sotto il profilo in esame. Nella surrogazione, infatti, la definizione del rapporto di genitorialità precede la nascita del bambino, mentre nell’adozione lo segue. L’esigenza di proteggere la relazione tra genitore e bambino in relazione alla nascita sussiste quindi nella surrogazione, mentre non si pone allo stesso modo nell’adozione.
Come si è detto, l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva in esame alla categoria di persone sopra citata costituisce l’effetto dell’esatta individuazione dello scopo perseguito dalla direttiva più che l’effetto di una possibile applicazione del principio di non discriminazione.
Allo stesso modo, sarebbe auspicabile superare l’idea secondo cui le discriminazioni sulla base della gravidanza e della maternità costituiscono delle discriminazioni dirette in base al sesso in re ipsa perché tale condizione può riguardare soltanto le donne. Certo, un trattamento deteriore rimane una discriminazione, ma sarebbe forse preferibile parlare di lesione del principio di uguaglianza dinanzi alla legge in quanto tale, piuttosto che porsi il problema di dover comunque individuare un c.d. motivo protetto [31].
Il problema delle situazioni transfrontaliere
La questione appare certamente più complessa nel caso in cui sia coinvolta una dimensione transfrontaliera, nel caso in cui cioè una persona si sposti dal paese di origine, che non ammette la surrogazione, in uno Stato membro che invece l’ammette, con la possibile conseguenza che gli effetti ricollegati da quest’ultimo in materia di genitorialità del padre e/o della madre affidataria possono non essere riconosciuti dal primo. In questi casi, non sarebbe corretto risolvere la questione basandosi unicamente sul divieto posto dallo Stato sul proprio territorio, ma, dal momento che è coinvolta una dimensione più articolata, appare necessario tenere conto e bilanciare tra loro tutti i diversi interessi in gioco, segnatamente quelli inerenti all’ordinamenti giuridico Ue, all’ordinamento giuridico dello Stato di origine e alle persone direttamente coinvolte.
Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico dell’Ue, è ben noto che il diritto alla libera circolazione costituisce un diritto fondamentale di tale ordinamento, strutturale e costitutivo dello stesso. Le limitazioni quindi non possono che essere di stretta interpretazione.
Più in dettaglio, sembrano incompatibili con il diritto alla libera circolazione dei servizi norme nazionali che abbiano lo scopo di impedire ai cittadini degli Stati membri di recarsi in un altro Stato membro per ricevere servizi collegati alla surrogazione, ancorché questa possa essere vietata nello Stato membro di origine. La giurisprudenza della Corte di giustizia sulla questione dell’aborto in Irlanda e la direttiva sulla libertà di movimento dei pazienti che codifica i principi elaborati dalla prima sembrano deporre in questo senso [32], anche se è vero che non necessariamente la surrogazione implica sempre e comunque l’erogazione di trattamenti di tipo sanitario [33].
Inoltre, è ben nota la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la tutela del diritto alla libera circolazione delle persone implica l’obbligo per uno Stato membro di riconoscere situazioni di status formatasi legalmente in un altro Stato membro [34], salvo il caso in cui entrino in considerazione principi fondamentali dell’ordinamento del primo. Si tratta di un punto peraltro su cui sembra consolidarsi un certo consensus anche a livello degli Stati membri.
A fronte di ciò, la posizione dello Stato di origine che non ammette la surrogazione non sembra particolarmente robusta. Innanzitutto, si deve considerare che la legislazione dei paesi in esame generalmente vieta la surrogazione nel paese di origine, ma non all’estero. Così, ad esempio, le persone sottoposte alla giurisdizione italiana possono andare lecitamente all’estero e concludere un contratto di surrogazione, se ammesso nel paese di destinazione. Si tratta di un approccio molto diverso rispetto all’atteggiamento assunto dal legislatore italiano in altri casi, come ad esempio in relazione alla criminalizzazione degli atti di pedofilia. Il problema è che il nostro legislatore non ha previsto alcuna disciplina delle conseguenze giuridiche di una tale scelta, ma questo costituisce per l’appunto almeno una parte del problema da risolvere. La scelta in esame peraltro sembra dimostrare la percezione da parte dello stesso legislatore nazionale che un divieto di questo tipo potrebbe entrare in conflitto con la decisione di aderire a una organizzazione ispirata al principio della libera circolazione e del mutuo riconoscimento degli ordinamenti giuridici.
A ciò va aggiunto che i motivi per i quali i legislatori interni, compreso quello italiano, vietano la surrogazione spesso non sono determinati dall’esigenza di proteggere principi fondamentali o inalienabili del loro ordinamento interno, segnatamente a livello costituzionale, ma da ragioni che riflettono scelte di merito, inerenti a particolari concezioni etiche, suscettibili di cambiamento qualora altre concezioni dovessero prevalere [35]. Ciò è particolarmente vero quando il divieto, come nel caso italiano, assume carattere assoluto, senza tentare alcuna mediazione che dimostri la ponderazione tra i diversi interessi fondamentali coinvolti.
Per quanto riguarda i diritti fondamentali delle persone coinvolte, a parte la posizione della madre surrogata e dei genitori affidatari, viene in rilievo in particolare l’interesse superiore del fanciullo, previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e accolto sia dalla giurisprudenza della Corte Edu che da quella della Corte di giustizia, anche in seguito alla previsione dello stesso nella CDFUE [36]. Occorre chiedersi cosa esiga tale interesse. Appare più coerente con quest’ultimo imporre al fanciullo la tutela della madre surrogata anche dopo la nascita? O appare preferibile ricorrere alle procedure di adozione? O attribuire rilevanza ai genitori affidatari riconosciuti come tali dal paese di destinazione, almeno in certi casi [37]?
Considerazioni come quelle appena effettuate non sembrano estranee alla giurisprudenza sia internazionale che interna. La Corte Edu, ad esempio, ha riconosciuto l’esistenza in Europa di un trend favorevole all’ammissione della donazione di gameti a fini di fertilizzazione in vitro. Secondo la Corte, esiste infatti un consenso emergente che impone di mantenere sotto costante revisione divieti stabiliti nel passato, sia da parte della Corte stessa che degli Stati contraenti. Se è vero che ha affrontato in modo accurato una questione che solleva problemi complessi dal punto di vista etico [38], il legislatore austriaco non ha tuttavia impedito ai singoli sottoposti alla propria giurisdizione di recarsi all’estero per beneficiare di trattamenti di infertilità proibiti in Austria e di prevedere regole specifiche sulla paternità e la maternità nel rispetto delle scelte dei genitori [39]. Non diversamente, la giurisprudenza italiana non ritiene in contrasto con l’ordine pubblico il riconoscimento di legami di filiazione formati secondo la legislazione in materia di surrogazione di un paese di civiltà affine [40]. Si tratta di un’interpretazione del concetto di ordine pubblico in linea con quello accolto dalla giurisprudenza italiana sin dalla fine dell’800 a proposito del riconoscimento dei divorzi celebrati all’estero e che ravvisa nell’ordine pubblico un istituto posto a difesa di principi considerati degni di universale valore giuridico dall’ordinamento nazionale [41].
Un tale bilanciamento sembra imporsi anche alla Corte di giustizia. Escludere dal godimento dei diritti di origine Ue a protezione della maternità e/o della paternità i genitori affidatari, infatti, non sembra realizzare un giusto contemperamento tra i diversi interessi in gioco, come sopra ricostruiti. Da una parte, infatti, una eventuale decisione della Corte di giustizia in senso positivo non avrebbe alcun effetto sulla scelta degli Stati membri di ammettere o meno la surrogazione nel loro ordinamento interno, questione su cui del resto la Corte non ha competenza, ma soltanto su diritti che l’Unione europea mira a conferire in modo uniforme a tutte le persone soggette alla propria giurisdizione. Dall’altra, non sembra che lo Stato possa porre a carico dei singoli delle conseguenze negative derivanti da condotte che considera lecite o che, in ogni caso, non sembrano riflettere la tutela di valori fondamentali nell’ordinamento giuridico del foro, quando invece rischiano di essere compromessi valori fondamentali dell’ordinamento giuridico Ue, quali il diritto alla libera circolazione. Non sembra quindi che la Corte possa attribuire al mancato riconoscimento della surrogazione in uno Stato membro l’effetto di privare un genitore affidatario riconosciuto come tale da un altro Stato membro del suo diritto al congedo di maternità, qualora esso si (ri)stabilisca nell’ordinamento di origine.
Conclusione
Rimangono i casi puramente interni, i casi cioè in cui si faccia ricorso alla surrogazione nell’ambito di un ordinamento che non l’ammette. Anche in questi casi, tuttavia, ci si deve chiedere se la situazione meramente fattuale non meriti alcuna considerazione da parte dell’ordinamento Ue, in particolare nell’ipotesi in cui l’ordinamento interno non intervenga tempestivamente, lasciando consolidare la situazione di fatto. Almeno in questa ipotesi, l’interesse superiore del fanciullo sembra esigere che il congedo di maternità sia comunque accordato al genitore che ha in custodia il bambino. Altro ovviamente è l’esito della problematica più generale, specialmente nell’ipotesi in cui la legge interna, come quella italiana, non disciplini le conseguenze dell’infrazione al divieto di surrogazione.
[1]Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1002, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in GUCE L 348/1.
[2]Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), in GUCE L 204/23.
[3]Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in GUCE L 303/16.
[4]Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Unione europea il 21 dicembre 2010. Cfr., decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in GUCE L 23/35.
[5]Cfr., considerando E e art. 1 della convenzione, secondo cui la disabilità “è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere compartimentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri (…)”.
[6]Il diritto dell’Unione non è univoco nell’uso terminologico. Mentre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea adotta attualmente il termine disabilità (la modifica è stata apportata a Strasburgo al testo originale adottato a Nizza), la direttiva di cui nel testo utilizza la parola handicap (cfr., art. 1). La Corte ricorre generalmente a quest’ultimo termine, mentre altri, come l’A.G. nella causa in oggetto, sembra preferire il termine disabilità, che in effetti appare più proprio. In considerazione della ratifica della Convenzione delle Nazioni unite e del cambiamento terminologico apportato dalla Carta, sembra preferibile che anche nella prassi degli organi giurisdizionali Ue e più in generale nella prassi degli organi dell’Unione si ricorra al termine disabilità.
[7]Corte di giustizia, 11 luglio 2006, caso Chacòn Novas, causa C-13/05, in Raccolta, p. I-6467 ss., p. 43.
[8]Corte di giustizia, 11 aprile 2013, caso HK Danmark, cause riunite C-335/11 e C-337/11, non ancora pubblicata in Raccolta, p. 38.
[9]Corte di giustizia, 11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11, caso Ring, non ancora pubblicata in Raccola.
[10] Peraltro, “se la concessione di un congedo retribuito dovesse essere assimilata alla riduzione dell’orario di lavoro”, occorrerebbe presumere che il lavoratore disabile ritorni senz’altro al lavoro una volta terminato il periodo di congedo, mentre non si può escludere che si rendano necessari ulteriori periodi di congedo nel caso in cui il lavoratore decida di avere altri figli.
[11] Secondo l’A.G., infatti, nel caso Ring., cit., la Corte avrebbe stabilito che la riduzione dell’orario di lavoro può essere considerata ragionevole a condizione che vi sia una corrispondente riduzione della retribuzione. In realtà, la citata sentenza non fa alcuna menzione della condizione in esame. Inoltre, sempre secondo l’A.G., riconoscendo come ragionevole la riduzione dell’orario, la Corte avrebbe accettato “che l’obbligo di una soluzione ragionevole possa interferire con la libertà del datore di lavoro di gestire i suoi affari, e possa implicare un onere finanziario”. E’ curioso che la determinazione dell’orario di lavoro sia considerata un’interferenza nella libertà del datore di lavoro di gestire i suoi affari.
[12]Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’affermazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, in GUCE L 39/40.
[13]Conclusioni Wahl, p. 63.
[14]Conclusioi Kokott, p. 87.
[15]Conclusioni Wahl, p. 64.
[16] Cfr., infra.
[17] Art. 16 direttiva 2006/54, cit. Secondo l’A.G. Wahl, tale obbligo implicherebbe che laddove il diritto interno preveda un congedo di adozione o comunque un congedo non subordinato alla condizione specifica di avere sostenuto una gravidanza, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce dello stesso diritto nazionale, se l’applicazione di norme diverse ai genitori adottivi e ai genitori che hanno avuto un figlio ricorrendo a un contratto di maternità surrogata e che siano riconosciuti genitori legali del figlio configuri una discriminazione, concl., p. 67.
[18] La Corte, infatti, considera la discriminazione basata sulla gravidanza e la maternità come una discriminazione diretta in re ipsa basata sul sesso: cfr., infra.
[19]Conclusioni Kokott, punto 86; conclusioni Wahl, p. 59.
[20]I criteri per determinare tale adeguatezza sono stabiliti al par. 1, p. 3 della medesima disposizione.
[21]Corte di giustizia, 26 febbraio 2008, caso Mayr, causa C-506/06, in Raccolta, I-1017, p. 50; caso Kiiski, cit, p. 55; 27 febbraio 2003, caso Busch, causa C-320/01, in Raccolta, p. I-2041 ss., p. 38; 5 maggio 1994, caso Habermann-Beltermann, causa C-421/92, in Raccolta, 1994, p. I-1657 ss., p. 15; 8 novembre 1990, caso Dekker, causa C-177/88, in Raccolta, I-3941, p. 12.
[22]Corte di giustizia, 20 settembre 2007, causa C-116/06, caso Kiiski, in Raccolta, p. I-7643 ss., p. 46; 14 aprile 2005, causa C-519/03, caso Commissione c. Lussemburgo, in Raccolta, p. I-3067 ss., p. 31 s.; 18 marzo 2004, causa C-342/01, caso Merino Gomez, in Raccolta, p. I-2605 ss., p. 32; 29 novembre 2001, causa C-366/99, caso Griesmar, in Raccolta, p. I-9383 ss., p. 43. Cfr., ora, in particolare, gli artt. 24, par. 3 e 7 della Carta DFUE.
[23]Corte di giustizia, caso Kiiski, cit., p. 35, caso Commissione c. Lussemburgo, cit., p. 32.
[24] Conclusioni A.G. A. Tizzano, caso Commissione c. Lussemburgo, cit., p. 72.
[25] Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES, rispettivamente considerazione generale n. 15 e clausola 2 dell’accordo allegato alla direttiva, che ha abrogato la direttiva 96/34/CE del Consiglio, 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.
[26] Corte di giustizia, caso Mayr, cit., p. 38 ss. Nel merito, essa ha considerato che, in caso di inseminazione artificiale l’inizio della gravidanza coincide con il trasferimento degli ovuli fecondati nell’utero della donna. Se infatti si facesse riferimento a un momento antecedente, quale quello della fecondazione in vitro degli ovuli prelevati, la tutela prevista dalla direttiva finirebbe con l’avere una durata irragionevole dato che, non di rado, gli Stati membri ammettono il congelamento degli ovuli fecondati anche per lunghi periodi. Ciò, tuttavia, non impedisce che in tale periodo non sia possibile alcuna tutela. Rimane infatti applicabile la direttiva 76/207, ora 2006/54/CE, la quale, così come interpretata dalla Corte, vieta a titolo di discriminazione diretta non solo il licenziamento durante il periodo della gravidanza, come la direttiva 92/85, ma anche il licenziamento basato sostanzialmente sullo stato di gravidanza: ivi, p. 50.
[27]A.G. J. Kokott, concl., p. 38.
[28] Il richiamo è alla sentenza Mayr, ct.
[29] Essendo giunta a una soluzione positiva, l’A.G. Kokott si pone anche il problema dell’applicazione in concreto della direttiva in particolare per ciò che concerne la ripartizione del diritto al congedo tra madre affidataria e surrogata. Poiché, come è logico, la direttiva non dice nulla al riguardo dato che si fonda sull’idea di un periodo di congedo ininterrotto attribuito a un’unica persona, secondo l’A.G., occorre fare riferimento alla tutela dei diversi interessi in gioco e alle indicazioni generali contenute nella direttiva. In base a tali criteri, si potrebbe riconoscere il periodo di congedo obbligatorio di almeno due settimane a entrambe le madri, mentre il restante periodo di dieci settimane andrebbe ripartito tra le due in funzione dei ruoli assunti da ciascuna di esse e alla luce delle disposizioni e prassi interne, cui la stessa direttiva fa rinvio. Gli eventuali effetti diretti dell’art. 8 della direttiva sarebbero quindi limitati al periodo di congedo obbligatorio e al caso in cui le madri interessate abbiano trovato un accordo sulla ripartizione delle settimane restanti, mentre per il resto la direttiva non potrebbe essere direttamente applicata. Tra le disposizioni analoghe cui si potrebbe fare riferimento in ambito interno vi sarebbero quelle che disciplinano il regime di solidarietà tra creditori.
[30] A.G. J. Kokott, concl., p. 64 ss.
[31] Cfr., art. 20 CDFUE. Se aiuta l’emersione di condizioni storiche di particolare sfavore, l’individuazione del c.d. motivo protetto non deve diventare tuttavia una sorta di limite ermeneutico insuperabile per l’interprete, come per molti versi sembra avvenire nel diritto europeo. In quest’ultimo, la rilevanza del motivo protetto si spiega largamente con i limiti di competenza materiale attribuiti storicamente, circoscritti appunto a assicurare il rispetto del principio di non discriminazione sotto profili ben delimitati. Una rivalutazione del principio di uguaglianza sembra pertanto auspicabile, almeno a partire dal momento in cui esso ha trovato una consacrazione espressa in ambito europeo.
[32] Parlamento Ue e Consiglio Ue, 9 marzo 2011, direttiva 2011/24/Ue concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in GUCE L 88/45. La direttiva riprende i principi enunciati dalla Corte di giustizia con il caso Grogan, 4 ottobre 1991, causa C-159/90.
[33] Come ad esempio nella surrogazione tradizionale.
[34] Cfr., in particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di riconoscimento dei nomi e più, in generale, ispirata al principio della c.d. unicità di status al fine di garantire la libertà di circolazione.
[35] A volte, le finalità della disciplina restrittiva non sono nemmeno specificate. Così, ad esempio, la l. 40/2014 non menziona le finalità che intende tutelare vietando in ogni caso forme di procreazione assistita di tipo eterologo. Un divieto così assoluto sembra giustificarsi soltanto con la volontà di preservare una particolare concezione di famiglia, senza prendere tuttavia in considerazione la tutela degli interessi fondamentali delle persone coinvolte in un eventuale possibile processo di procreazione assistita.
[36] Cfr., art. 24 Carta DFUE. Cfr., altresì, art. 3 par. 3 alinea 2 del TUE.
[37] Su queste questioni dovrà pronunciarsi la Corte Edu nel caso Mennesson e a. c. Francia, attualmente pendente.
[38] Adducendo ragioni morali, di accettazione sociale e la necessità di evitare che due donne possano contemporaneamente invocare la propria maternità sullo stesso bambino al fine di vietare la donazione di gameti per la fertilizzazione in vitro.
[39] Corte Edu, 3 novembre 2011, caso S.H. c. Austria, p. 96 ss. e 114. La Corte ha seguito lo stesso ragionamento in relazione alla questione dell’aborto vietato in Irlanda: Corte Edu, 16 dicembre 2010, A.B.C. c. Irlanda, p. 239. Il caso S.H. c. Austria va distinto dal caso, attualmente pendente dinanzi alla stessa Corte, Paradiso e Campanelli c. Italia, in cui manca qualsiasi legame di carattere genetico e biologico tra entrambi i genitori che sono ricorsi a un contratto di surrogazione in Russia e il bambino. Secondo i giudici interni, tale caso sarebbe in conflitto con l’ordine pubblico in quanto costituisce un tentativo da parte dei coniugi di aggirare le norme sull’adozione. Questa interpretazione di per sé non appare corretta in quanto, mentre l’adozione si riferisce a un bambino già nato, il contratto di surrogazione riguarda un bambino che deve ancora nascere, con tutte le conseguenze del caso. Le due situazioni, quindi, non sono assimilabili.
[40] Corte d’appello di Bari, 13 febbraio 2009, che riconosce nell’ordinamento giuridico italiano il parental order emanato dal giudice inglese con cui quest’ultimo aveva riconosciuto come figlio di una coppia affidataria il bambino nato in seguito a un contratto con la madre surrogata e genetica in quanto ciò non contrasta con l’ordine pubblico internazionale; Tribunale di Napoli, 1 luglio 2011, che riconosce come figlio di un padre affidatario e genetico due bambini nati in seguito a un contratto di surrogazione in Colorado in quanto il divieto della surrogazione nell’ordinamento italiano non si basa su valori costituzionali riguardanti la protezione dei bambini, ma su una scelta del legislatore.
[41] P. Mengozzi, Diritto internazionale privato, 1987, p. 66 ss.
[whohit]BALBONI surrogazione[/whohit]



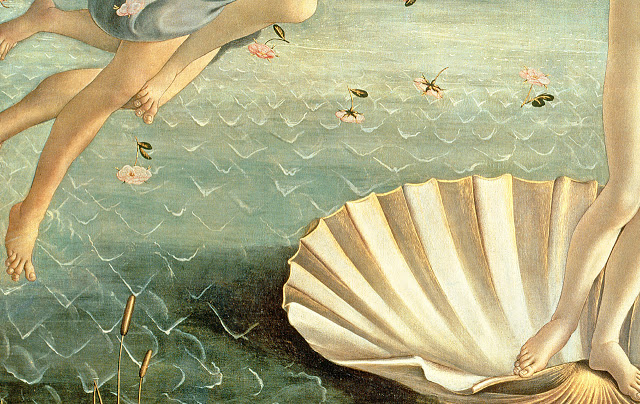
[…] M. Balboni, Gli Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea e la surrogazione di maternità, in https://www.articolo29.it , cui si rimanda per più ampi riferimenti e per le indicazioni relative agli […]