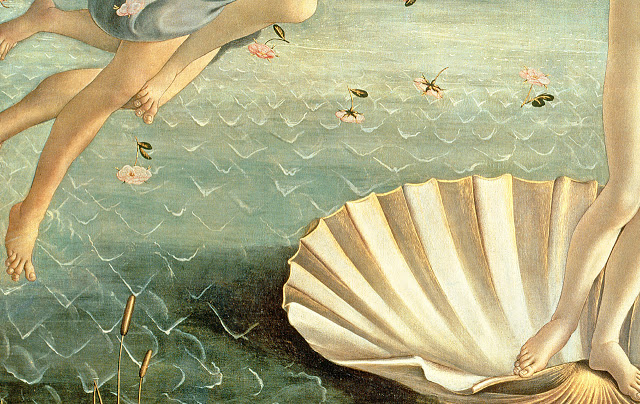Un’altra storica decisione della Corte Suprema: è illegittimo licenziare un lavoratore perché omosessuale o transgender
| 29 giugno, 2020 | Filled under discriminazione, internazionale, OPINIONI |
|
di Angioletta Sperti*
Dopo la nota pronuncia (Obergefell v. Hodges) con cui nel 2015 dichiarò incostituzionali i divieti statali ai same-sex marriages, estendendo a tutti gli Stati Uniti il diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso, con una nuova storica decisione la Corte Suprema ha riconosciuto che, in base al diritto federale, nessun lavoratore può essere licenziato perché omosessuale o transgender.
La sentenza, Bostock v. Clayton County, Georgia, riunisce tre ricorsi sollevati da alcuni lavoratori a tempo indeterminato licenziati per il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere: il caso di Gerald Bostock, licenziato dalla contea di Clayton in Georgia per condotta “inappropriata” dopo essere entrato a far parte di un gruppo sportivo gay; il caso di Donald Zard licenziato dalla Altitude Express dopo aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità ed, infine, il caso di Aimee Stephens dipendente della Harris Funeral Homes, licenziato dopo aver comunicato al datore di lavoro la propria intenzione di “vivere a lavorare a tempo pieno come donna”.
Ciascuno dei ricorrenti aveva contestato la legittimità del licenziamento in base al Civil Rights Act del 1964 (Titolo VII dello U.S. Code) che vieta la discriminazione nei luoghi di lavoro in base alla razza, al colore della pelle, alla religione, al sesso ed alle origini nazionali. La difesa dei lavoratori adduceva, in particolare, che un datore di lavoro che licenzia una persona perché omosessuale o transgender adotta di fatto tale decisione per caratteristiche personali o per atti che non avrebbe considerato “problematici” in soggetti di sesso diverso. In Bostock la Corte Suprema accoglie, quindi, questa interpretazione chiarendo che “il sesso ha giocato un ruolo necessario ed indistinguibile nella decisione” dei datori di lavoro di licenziare, come vietato dal Titolo VII.
La decisione è stata assunta dalla Corte Suprema con una maggioranza di 6 giudici su 9. A favore hanno votato, infatti, anche alcuni dei suoi componenti di orientamento conservatore, come il Presidente della Corte, il giudice Roberts (che in Obergefell aveva criticato, in un’opinione dissenziente, il ruolo creativo della Corte nell’estensione del diritto al matrimonio) e il giudice Gorsuch, nominato da Trump, che è peraltro l’estensore della pronuncia.
Il profilo su cui si incentra la motivazione è quindi la corretta interpretazione della formula “a causa del sesso” (because of sex) che il Titolo VII individua come illegittima causa di discriminazione verso il lavoratore. Il giudice Gorsuch, seguendo una una tecnica di interpretazione rigidamente aderente al testo della legge (textualism) – da lui stesso giudicata in passato come la più corretta e brandita dal giudice Scalia come una bandiera contro l’attivismo giudiziario della Corte Suprema in tema di diritti civili – sostiene che la conclusione della Corte a favore del lavoratore discende come “diretta applicazione del Titolo VII, interpretato in base al significato ordinario delle parole al momento della loro adozione”.
La maggioranza della Corte, dunque, sostiene che la formula vada intesa come “in ragione del sesso” o “tenuto conto del sesso” e che essa trovi applicazione ove il sesso costituisca la ragione necessaria (anche se non sufficiente) della decisione del datore di lavoro di non assumere, licenziare o, in generale, discriminare nei confronti del lavoratore. “Questo significa – precisa la Corte – che il datore di lavoro non può esimersi dalla responsabilità adducendo qualche altro fattore che abbia contribuito alla decisione impugnata dal lavoratore. Ove il sesso abbia costituito un motivo necessario [del licenziamento], ciò è sufficiente per consentire l’applicazione della legge” (§ A).
Sempre attenendosi ad un’interpretazione letterale, la Corte precisa inoltre che la «discriminazione» consiste nel riservare ad una persona un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello riservato ad altri soggetti posti nella stessa situazione e che per essere illegittima la discriminazione deve essere (oltre che intenzionale) «individuale», ossia diretta al soggetto in quanto tale e non in quanto appartenente ad un gruppo.
Si tratta di una precisazione particolarmente rilevante in quanto consente di superare quell’eccezione, spesso ricorrente nelle argomentazioni di chi pone in essere discriminazioni verso la comunità LGBTQ, relativa alla neutralità rispetto al sesso della scelta adottata, ossia l’idea che quest’ultima sarebbe stata assunta anche qualora il soggetto leso fosse stato di sesso diverso. Si pensi, ad esempio, al caso del datore di lavoro che licenzi una donna per il suo aspetto poco femminile, adducendo che avrebbe preso la medesima decisione verso un uomo dall’apparenza poco mascolina. La discriminazione – spiega quindi la Corte Suprema – non può essere valutata in termini relazionali: «in entrambe le situazioni il datore di lavoro licenzia un individuo in parte a causa del suo sesso» e pertanto la sua decisione «non sfugge all’applicazione della legge, anzi la viola doppiamente».
Sulla base di queste premesse la maggioranza della Corte ritiene semplice e memorabile (simple and momentous) il messaggio espresso dal Titolo VII e sottolinea che “l’omosessualità e lo status transgender non sono rilevanti per le decisioni che attengono al rapporto di lavoro: questo perché è impossibile discriminare contro una persona in quanto omosessuale o transgender senza discriminare quella persona in base al sesso”.
Alla obiezione secondo cui sesso ed orientamento sessuale sono concetti distinti, il giudice Gorsuch replica osservando che “quando un datore di lavoro licenzia un lavoratore perché omosessuale o transgender, due fattori causali vengono in gioco: il sesso dell’individuo e qualcos’altro (in particolare il sesso verso cui l’individuo è attratto o con cui si identifica). Tuttavia, ciò non rileva ai fini dell’applicazione del titolo VII. Quando il datore di lavoro non avrebbe licenziato il lavoratore se non fosse stato di quel sesso, il nesso causale richiesto dalla legge è soddisfatto e ne consegue la responsabilità”.
Né secondo la Corte si deve dare rilevanza al fatto che il testo normativo non menzioni espressamente l’orientamento sessuale quale fattore di discriminazione, poiché ciò implicherebbe l’esenzione del datore di lavoro da ogni responsabilità: “un datore di lavoro che intende discriminare [sull’orientamento sessuale] inevitabilmente intende basare la propria decisione sul sesso”. “Certamente, l’obiettivo finale del datore di lavoro può essere quello di discriminare in base all’orientamento sessuale, ma per realizzare tale intento egli deve, nel suo ragionamento, trattare peggio ed intenzionalmente un lavoratore in parte per il sesso di quell’individuo”. “La discriminazione basata sull’omosessualità o sulla condizione transgender necessariamente implica la discriminazione basata sul sesso, poiché la prima non può realizzarsi senza la seconda”.
La Corte conclude, quindi, che i casi in esame non rappresentano che “la diretta applicazione di termini giuridici di chiara e consolidata interpretazione”. È quindi irrilevante come un datore di lavoro qualifichi la discriminazione. “Sebbene – aggiunge la Corte Suprema – nei casi di specie i datori di lavoro non mettano in discussione il fatto di aver licenziato i dipendenti perché omosessuali o transgender e ritengano che tale fattore di discriminazione non sia stato espressamente previsto dal Titolo VII, nessuno dei loro argomenti in merito all’intento della legge […] consente di ignorare ciò che la legge dice”.
Nel seguito della pronuncia il giudice Gorsuch replica puntualmente alle ulteriori obiezioni avanzate dai datori di lavoro (fra cui l’assenza di un intento discriminatorio in base all’orientamento sessuale), ma soprattutto si concentra sul ruolo delle corti nel definire dell’ambito di applicazione della legge. All’eccezione – avanzata anche nelle opinioni dissenzienti (Alito e Thomas) – secondo la quale “nel 1964 nessuno si sarebbe mai aspettato che la legge avrebbe trovato applicazione anche alle discriminazioni verso le persone omosessuali o transgender” e che l’applicazione a queste categorie di persone avrebbe richiesto il necessario intervento del legislatore, la maggioranza replica ribadendo la distinzione tra significato letterale del testo normativo e risultato che consegue alla sua applicazione. Respingendo, in termini molti netti, l’assunto secondo cui sia dovere dei giudici attenersi solo “alle applicazioni attese” (expected applications) della legge, la Corte scrive: “Spesso dietro queste obiezioni si cela la cinica considerazione secondo cui il Congresso non poteva avere inteso proteggere un particolare gruppo svantaggiato. […] L’applicazione di leggi protettive a gruppi politicamente impopolari nel momento in cui la legge fu approvata […] può spesso apparire inattesa. Ma rifiutare tale applicazione […] implicherebbe non solo di abbandonare il nostro ruolo di interpreti della legge, ma di far pendere la bilancia della giustizia dalla parte di chi è forte e popolare e disattendere la promessa per cui tutte le persone hanno diritto di beneficiare dei termini della legge”.
La decisione della Corte Suprema in Bostock v. Clayton County ha come immediata conseguenza quella di estendere la tutela dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere nei luoghi di lavoro a tutto il territorio degli Stati Uniti, dunque anche a quella metà degli Stati che sino ad oggi non hanno approvato leggi volte a prevenire tali forme di discriminazione. Il Civil Rights Act, tuttavia, si applica solo ove il datore di lavoro impieghi almeno 15 dipendenti e certamente, come è stato osservato, la pronuncia non risolve nell’immediato tutte le difficoltà che le persone LGBTQ spesso si trovano a fronteggiare nei luoghi di lavoro: si pensi, per esempio, a quelle connesse ad aspetti pratici della vita lavorativa come la tutela dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale nell’utilizzo delle strutture (bagni, armadietti, ad esempio) o nei riguardi dei dress codes spesso imposti dal datore di lavoro.
Tuttavia, sia i giudici dissenzienti che la stessa maggioranza non negano che la pronuncia avrà conseguenze che vanno al di là dei casi di specie: è dato, infatti, prevedere che l’interpretazione avanzata dalla Corte Suprema in relazione al Titolo VII sarà presto invocata in altri contesti in cui le leggi federali vietano il “sesso” come fattore di discriminazione o lo richiamano come criterio per l’accesso a strutture, attività sportive, assistenza sanitaria. Il giudice dissenziente Alito sottolinea questo aspetto con particolare enfasi, scrivendo che “la posizione oggi adottata dalla Corte minaccerà la libertà religiosa, di espressione, la privacy e la sicurezza”: a suo parere la sentenza avrà conseguenze negative, ad esempio, sull’uso della lingua da parte degli insegnanti (ad esempio sull’uso del maschile al posto di termini riferibili ad entrambi i generi) o sulla possibilità dei datori di lavoro di esprimere la propria posizione verso l’omosessualità o le proprie convinzioni religiose in tema di matrimonio.
La maggioranza su questo punto di fatto non replica, limitandosi a sottolineare che oggetto della pronuncia è la sola questione del licenziamento del lavoratore omosessuale o transessuale. Lo stesso Civil Rights Act prevede peraltro esplicitamente che le sue disposizioni non si applicano alle “religious corporations” “riguardo ai rapporti di lavoro con soggetti di una particolare religione per lo svolgimento di un lavoro connesso alle loro attività” (Sec. 702 (a)).
Tuttavia, è a mio parere prevedibile che questa pronuncia, al pari di altre storiche decisioni del passato (come Brown v Board of Education che nel 1954 mise fine alla segregazione razziale), produca conseguenze in termini di avanzamento della tutela per le persone LGBTQ in contesti che vanno ben al di là di quello lavorativo. Non si deve, infatti, dimenticare che nella sua giurisprudenza sui diritti delle persone LGBTQ e delle coppie dello stesso sesso, la Corte Suprema – non diversamente da altre corte costituzionali – ha spesso ragionato in termini di dignità, autodeterminazione, eguaglianza degli individui, senza però mai spingersi a qualificare l’orientamento sessuale come un fattore vietato di discriminazione. Ciò, presumibilmente, per le rilevanti implicazioni che una tale affermazione avrebbe prodotto nei futuri giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto disparità di trattamento verso le persone LGBTQ: includere l’orientamento sessuale tra le discriminazioni di per sé sospette (suspect classifications) avrebbe infatti determinato l’applicazione di standards of review molto più rigorosi e posto una presunzione di incostituzionalità per le disparità di trattamento, al pari di quanto avviene per quelle fondate sul sesso, sulla razza, sulle opinioni politiche.
Il ragionamento attraverso cui oggi la Corte Suprema in Bostock fa confluire l’orientamento sessuale e l’identità di genere nel sesso, quale fattore di discriminazione vietato dalla legge – per quanto discutibile da un punto di vista concettuale – può, quindi, oggi indicare ai movimenti LGBTQ, non solo americani, una strategia per aggirare alcune strettoie del giudizio di legittimità costituzionale in tema di eguaglianza formale. E ciò, come sottolinea la Corte Suprema, nel pieno rispetto della lettera della legge.
* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, Università di Pisa.